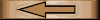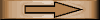|
|
CONGRESSO APOSTOLICO MONDIALE DELLA MISERICORDIA |
||
|
di Luigi Alici |
|
||
|
A Roma dal 2 al 6 aprile si è
celebrato il Congresso Apostolico Mondiale della
Misericordia. Anche il nostro Santuario ha portato il suo
contributo a questo importante Convegno con l’intervento del
vescovo di Città di Castello Mons. Domenico Cancian FAM, con
la testimonianza della superiora generale delle Ancelle
dell’Amore Misericordioso Madre Speranza Montecchiani, e con
le puntuali e profonde riflessioni del Presidente
dell’Azione Cattolica Italiana il Prof. Luigi Alici.
Riportiamo con piacere l’ultima parte
della relazione del Prof. Alici.
|
|||
LA MISERICORDIA COME PROFEZIA CULTURALE
3. L indebolimento postmoderno
La cultura moderna ha pagato a caro prezzo la propria pretesa di secolarizzare le domande di senso, entrando in competizione con la risposta religiosa a tali domande. Quella pretesa ha continuato a essere mantenuta alta, anche quando il primato di una razionalità autosussistente, capace di proporsi non solo come organo di conoscenza ma addirittura come fonte di verità, veniva attaccato sistematicamente. Mentre molti «maestri del sospetto»1 scalzavano sin dalle fondamenta l’edificio solido della ragione moderna, le sicurezze che essa aveva promesso dovevano affidarsi alle ideologie per poter continuare a esercitare il loro fascino. Ma anche questo presidio ideologico era destinato a esaurirsi, e gli eventi di questo scorcio di secolo lo attestano in modo inequivocabile.
Quando ormai il sospetto sulla purezza della razionalità è stato seminato a piene mani è difficile tornare indietro: la ragione appare come uno strumento «torbido» e mistificante, che cerca malamente di coprire interessi di classe o una lotta scatenata di pulsioni e di istinti, che si consuma alle spalle della coscienza. Nel momento in cui la razionalità umana si dichiara incapace di raggiungere e dominare le radici delle tensioni storiche o della vita psichica, l’ombra del nichilismo ha ormai cominciato ad allungarsi, in modo lento e inarrestabile, su tutte le possibili risposte alle grandi domande di senso. Appare perciò inutile avventurarsi su quel terreno che molte filosofie avevano tentato di contendere alle religioni: il senso, come sostiene ad esempio Lévi-Strauss, «proviene sempre dalla combinazione di elementi che non sono essi stessi significanti»2, e dunque «dietro a ogni senso si da un non senso»3. La crisi della modernità comincia con la perdita delle risposte e rischia di finire con la perdita delle domane.
Probabilmente oggi stiamo vivendo questa fase intermedia in cui molte certezze sono cadute, l’onnipotenza della ragione si è capovolta nell’impotenza del nichilismo, e sulle insicurezze postmoderne stende il suo velo disincantato ed evasivo il pensiero debole. Dinanzi a un assetto sociale sempre più policentrico non si guarda più alla frammentazione del senso come a un limite da combattere ma come a una condizione insuperabile da accettare. In un universo nel quale convivono, quasi fosse un supermarket, tante «tribù culturali», dissimili nella loro superficie variopinta ma sostanzialmente omologate e insignificanti, piccoli mondi vitali di consumo simbolico a prezzi scontati, la ragione paga la propria rinuncia a guardare lontano con la più crudele delle condanne: assistere muta alla rivalsa degli affetti, alla banalizzazione del senso e alla polverizzazione delle domande grandi. Ciò che appariva troppo debole agli occhi del razionalismo moderno ora riacquista un credito un tempo impensabile, anche se il desiderio si abbassa al livello di una fruizione del vissuto, dal sapore quasi neopagano, con il suo corredo di minuscole idolatrie politeistiche e con le sue tavole dei comandamenti rovesciate4.
In questo contesto l’amore sembra prendersi una rivincita, ma la sua è, in un certo senso, una vittoria di Pirro; piantando la propria bandiera sulle regioni un tempo egemonizzate dalla cultura illuministica, vi trova soltanto un terreno arido e bruciato: dal cinismo, dall’utilitarismo, dall’indifferenza, dall’impassibilità, che sono gli effetti collaterali di una malattia della ragione durata troppo a lungo e non sempre curata adeguatamente5.
La prima conseguenza di questa nuova situazione può essere senz’altro individuata in una diffusa banalizzazione dell’amore; svincolato dal discernimento dell’intelligenza e dalla responsabilità della coscienza, ormai immune anche dalle intense idealità passionali tipiche della cultura romantica, l’amore diventa uno stile estetico-emozionale, che può impreziosire la fenomenologia dei rapporti corti, un genere di consumo estetico ed edonistico, a metà strada tra emozione e piacere, attraverso cui inseguire voglie epidermiche e avventurarsi in un gioco leggero di relazioni fragili e disimpegnate. L’idea che la libertà più alta possa realizzarsi all’interno di un ordo amoris, di un cammino esigente e orientato verso il bene appare semplicemente inconcepibile. In tale prospettiva la possibilità stessa di una vocazione religiosa alla verginità o di un vincolo coniugale in grado di assumersi la responsabilità della procreazione e il coraggio della fedeltà, viene colpita alla radice, mentre il piacere sessuale diventa il polo catalizzatore di tutta la dimensione pulsionale e affettiva, scatenando in modo parossistico i suoi appetiti arbitrari e spregiudicati.
Una seconda conseguenza può essere individuata in una netta separazione tra dimensione privata e pubblica; la prima coincide con la sfera del vissuto soggettivo, mentre la seconda rappresenta un livello lontano e inautentico, sul quale semmai si riversa un accanimento moralistico. Nella vita privata il buono viene assimilato al piacevole, nella vita pubblica al legale: mentre le questioni valutative sono affidate a opzioni in ultima analisi insindacabili, le questioni normative investono unicamente il mondo convenzionale delle regole. Mentre, quindi, si rifiuta con estrema disinvoltura qualsiasi invadenza etica nella sfera delle abitudini di vita «private», si invocano al contrario misure severamente prescrittive nella sfera della moralità pubblica. Inutile dire quanto questa separazione sia in se stessa del tutto arbitraria, limitandosi a capovolgere l’ideologia del «tutto è politico», dominante fino a qualche decennio fa: come sostenere ad esempio che l’aborto o la fecondazione artificiale o l’eutanasia siano questione privata, quando investono l’assetto giuridico, le risorse economiche, le abitudini sociali di un’intera comunità?
In terzo luogo, in una cultura che impoverisce il valore del bene e lo priva di tutta la sua forza metafisica di attrazione, anche il male si spoglia di ogni enigmatica tragicità, assumendo la fisionomia ben più modesta e pragmatica di uno sfortunato incidente di percorso. A livello fisico ogni fenomeno difettivo viene perciò interpretato come una sventura dovuta alla fatalità, mentre a livello morale prevale l’idea legalistica del male come infrazione a una legge positiva e codificata; dell’originaria figura religiosa del peccato, come atto libero di orgogliosa autoaffermazione dell’io davanti a Dio, resta una controfigura pallida e sbiadita, che veicola semmai oscuri sensi di colpa affidati all’analisi liberatoria dello psicanalista.
Viene a perdersi di conseguenza l’idea di un divario incommensurabile tra bene e male, che vanifica il senso stesso della misericordia. Tutte le forme deboli di condivisione empatica nascono infatti sulla base di una sostanziale equivalenza tra bene e male: ogni esperienza vale l’altra, siamo tutti sulla stessa barca, comprendere significa semplicemente accettare l’esistente. Al contrario, la misericordia nasce proprio dal riconoscimento dell’abisso del male, che non può essere colmato lasciando le cose come stanno; essa quindi non è nemica della verità e della giustizia, ma deve la sua forza proprio alla capacità di attraversare una distanza realmente grave e profonda, che chiede di essere riconosciuta e sanata.
Va infine ricordato il modo in cui la cultura post-moderna concepisce la vita di relazione. In una società sempre più ondeggiante tra comunicazione e solitudine, tra l’apertura a uno spettro sconfinato di virtualità telematiche e la ricerca di un contatto immediato e diretto con l’altro, si privilegiano esperienze selettive e ravvicinate di prossimità, che riportano drammaticamente in primo piano la domanda evangelica: «Chi è il mio prossimo?». Quando l’incontro tra l’io e il tu tende a escludere la «terza persona», cioè il lontano, l’estraneo, colui che vive in una condizione diversa e inferiore rispetto alla nostra, esso si preclude la possibilità di riconoscere ed edificare la dimensione del «noi» nella prospettiva di un’autentica fraternità solidale. Una convivenza posta sotto il segno di una «fraternità mancata» finisce con l’emarginare i valori della solidarietà e della sollecitudine nei circuiti compensativi della testimonianza individuale, accontentandosi di gestire l’arbitraggio degli interessi e rinunciando a immettere nei diversi strati della vita civile e politica benefici fermenti di socialità virtuosa. La sfida per noi credenti comincia proprio qui: quella «logica del primo passo», che media l’incontro tra Dio e l’uomo, è esportabile al di fuori del rapporto religioso? È in grado di promuovere anche il rapporto tra persona e persona, così come tra persona e natura, frequentando i luoghi pubblici e solo apparentemente «neutrali» delle istituzioni e dell’ethos, dell’economia e della politica, del diritto e della cultura? Come può avere diritto di circolazione, in un mercato dominato dalla inflessibile contabilità del dare e dell’avere, una moneta diversa? Non è già molto tollerare gli spiccioli facoltativi della generosità personale? Una carità riscoperta come principio generatore di cultura e di storia potrà essere allora solo rimedio riparatore, pronto a correre incontro alle urgenze della povertà, dispensando gesti eroici di beneficenza, incapaci però di scalfire la gabbia d’acciaio dei poteri forti e degli egoismi consolidati? Oppure dovrà essere anche principio generatore, anima ispiratrice, motivazione progettuale, implementando l’ordine della giustizia, senza sconfessarlo?
4. La misericordia come ulteriorità della giustizia
Provare ad aggiungere qualche considerazione finale, in positivo, a questa breve analisi non è facile: siamo tutti figli di un’epoca troppo ricca di analisi e troppo povera di progetti. La stessa scelta di impegnarsi in un «progetto culturale orientato in senso cristiano» da parte della nostra comunità ecclesiale attesta una esigenza fondata e diffusa: una cultura che «sa leggere» ha bisogno di una cultura che «sa scrivere». Naturalmente questo compito non può essere assolto con qualche sporadica iniziativa intellettuale ma esige una partecipazione corale e convinta, che sappia elaborare modelli di discernimento e di comportamento, incarnare esperienze esemplari e riproducibili, elaborare un quadro valoriale alto e significativo, sussidiarlo con una rete di cammini formativi equilibrati ed efficaci. La cultura diventa costume solo se sa avvalersi di una rete di protezione e di «istituzioni amiche» in cui principi, convinzioni e idee possano irrobustirsi, crescere e incidere sul tessuto sommerso del costume.
Posso perciò limitarmi ad alcuni semplici spunti, che nascono da una ferma convinzione: l’anima di tale progetto culturale potrà essere rappresentata adeguatamente solo dal vangelo della carità; più precisamente da una interpretazione radicale e alta della carità, che non la riduca a uno slogan indolore ed esangue con cui cercare di vivacizzare una pastorale spenta e anemica. Nell’epoca della frammentazione e della complessità, alla comunità cristiana non si chiede di attardarsi a puntellare il proprio edificio fatiscente con un supplemento di attivismo pastorale o di moniti moralistici. Si chiede piuttosto di ritornare all’essenziale e di rispondere all’impoverimento diffuso del senso della vita con un atto straordinario di amore. Un amore misericordioso, appunto, non potrà che essere l’anima di questo progetto culturale, la scelta strategica fondamentale con la quale i cristiani possono rendere credibile la grande conversione alla misericordia alla quale ci invita la celebrazione del Giubileo.
Provo quindi a suggerire qualche varco attraverso il quale il messaggio della misericordia può raggiungere il mondo della cultura, per rianimarlo e fermentarlo.
Come primo passo occorrerà ricordare che la misericordia è prima di tutto un dono, non un sentimento; nella sua cifra più autentica essa è profezia di trascendenza, che racchiude in sé il mistero delle origini. Tutto il nostro essere, infatti, è «impastato» di gratuità; le nostre fibre più profonde attestano il senso di una finitezza, di una creaturalità, di un debito che solo una cultura narcisistica e autocentrata può occultare. Qui si apre lo spazio di una teologia dell’amore misericordioso che in questo libro viene esplorata in alcuni tratti fondamentali. Ora però ci interessa il riverbero culturale di questa teologia, cioè la sua capacità di illuminare il desiderio del cuore, lo sguardo dell’intelligenza, la testimonianza della vita, le forme della convivenza.
Se è vero che cultura è elaborazione di un universo di senso, in virtù del quale la comunità umana continua storicamente il processo di creazione e promozione della natura, perché privarsi di quei germi di gratuità misericordiosa che spezzano l’assedio utilitaristico? E questo non solo per una sorta di equilibrio estetico tra ordine e libertà6, ma prima di tutto nel nome di una vera e propria conversione dell’intelligenza; il frutto di tale conversione dovrà essere il rovesciamento completo di un modello culturale che interpreta la vita nella prospettiva del prendere, anziché in quella del ricevere; che antepone la logica dell’avere e del potere a quella dell’accogliere e dell’essere; che non riesce a guardare oltre il piano del calcolo e del tornaconto. Una cultura che non è in grado di riconoscere e apprezzare il valore del dono e della grazia difficilmente potrà aprirsi alla verticalità della trascendenza.
Si potrebbe aggiungere, inoltre, che alla misericordia come rivelazione dell’illimitato amore di Dio corrisponde nell’uomo una misericordia vissuta come virtù etica, vale a dire come sintesi di compassione e beneficenza. Essa infatti coniuga un lato «passivo» e un lato «attivo»: il primo è rappresentato dalla disponibilità a lasciarsi toccare dalla miseria dell’altro, fino a farsi carico della sua sofferenza; la compassione è infatti una forma elementare di condivisione, che consiste nel diventare compagno del misero fino ad assumere la sua condizione, a farsi espiazione ed ostaggio, come ci ha ricordato con forza Emmanuel Lévinas. Il secondo lato è però quello attivo della beneficenza, che risponde all’«eccesso di male» con un «eccesso di bene», capace di elevare, promuovere, riscattare.
Due sono, in fondo, i modi possibili attraverso i quali, come osservava già Kierkegaard nel secolo scorso, l’amore può colmare la distanza infinita tra l’uomo e Dio: quello dell’elevamento del discepolo, come avviene nel re che sposa una fanciulla di umili condizioni, illudendosi di comprare il suo amore con lo splendore della magnificenza regale, e quello dell’abbassamento del maestro, del re che rinuncia al suo rango, per scendere allo stesso livello dell’altro, per farsi povero con i poveri7. L’abbassamento, però, non è mai fine a se stesso ma contiene un momento positivo, dinamico, capace di far risalire la china verso il bene. Per questo la misericordia non è cieca davanti al male, non è sprovveduta dinanzi al suo fascino diabolico; essa si abbassa per sottrarre l’altro alla sua schiavitù, non per mantenersi al suo livello. Il paradigma supremo di questa dialettica di abbassamento e di elevazione ci è offerto dalla redenzione di Cristo, il quale, come ci ricorda san Paolo, non ha considerato un tesoro geloso la propria natura divina, ma ha voluto sprofondarla nell’abisso della miseria e della sofferenza, aprendo in tal modo una via salvifica di riscatto dal peccato.
Mentre la cultura moderna si esaltava dinanzi all’atto «forte» della liberazione e guardava con sospetto al momento passivo della kenosis, la cultura contemporanea al contrario sembra prediligere tale momento, fino a ricercarne una discutibile legittimazione teologica, arrivando a parlare di impotenza di Dio8. Sul piano culturale occorre contrastare questa visione mutila e unilaterale di amore misericordioso, che la priva del suo momento attivo e dinamico, che le impedisce di espandersi in forza benefica ed esigente, capace di riconoscere il male, di contrastarlo energicamente.
Il suo compito è introdurre un «terzo paradigma», accanto a quello utilitaristico, fondato sulle decisioni e i calcoli degli individui, e a quello olistico, che al contrario proclama il primato della totalità sociale: il paradigma del dono, che immette nella logica contrattuale del mercato e in quella giuridico-istituzionale dello Stato una rete alternativa di circolazione di beni e di servizi9. Proprio questa rete invisibile di sostegno oggi rappresenta il prolungamento dell’antico regime del dono, tipico delle società primitive10. Sin dalle sue forme più arcaiche, tale regime non è estraneo a una elementare relazione di reciprocità, anche se diversa da quella, simmetrica e bilaterale, che la giustizia controlla attraverso il bilanciamento dei diritti e dei doveri. La gratuità del dono, infatti, lo sottrae all’obbligo di una restituzione, ma istituisce ugualmente una forma di responsabilità diversa da quella puramente contrattuale e legalistica: la responsabilità libera e insieme vincolante della gratitudine. La dimensione virtuosa della misericordia si realizza attraverso questo arduo tirocinio di solidarietà attiva che genera un clima di rispetto e di dedizione, capace di sostituire al circolo vizioso del sospetto il circolo virtuoso della fiducia11. È difficile negare che la nostra convivenza non abbia bisogno di questa ricca ossigenazione morale.
Infine, il nostro habitat culturale ha bisogno di una lungimiranza profetica, capace di dilatare e di personalizzare lo sguardo della giustizia. «La giustizia », come ci ha ricordato Ricoeur, «con la sua logica di equivalenza, è la più alta conquista della morale umana»12; una giustizia, beninteso, impegnata a rendere a ciascuno il suo in nome di una uguaglianza di opportunità, garantendo così un ordine legittimamente costituito contro gli assalti della violenza illegittima. La carità invece, egli aggiunge, conferisce «alla sollecitudine uno statuto più fondamentale di quello dell’obbedienza al dovere»13; essa infatti ricava un vero e proprio principio di cooperazione dall’idea paolina del mutuo indebitamento (Rm 13,8).
Un amore autenticamente misericordioso non introduce quindi un fattore anarchico nell’ordine giuridico14, ma un doppio movimento di espansione: in avanti e all’indietro, caratterizzandosi appunto come «avanguardia» profetica e «retroguardia» caritativa, insomma come ulteriorità della giustizia, in grado cioè di dilatare gli orizzonti del bene comune ma anche di accogliere e riscattare le vittime della sopraffazione. Per la sua capacità di instaurare una relazione diretta con l’altro, con la sua individualità ferita e mortificata, la misericordia resta eminentemente una virtù personale, ma non privata: la promozione della persona è un atto pubblico per eccellenza, che ha una ricaduta sociale e culturale solo se riesce a incarnarsi in un ethos permeabile alle istanze della dedizione e del perdono. Del resto, come la storia ci insegna, molte delle istituzioni che oggi si presentano ai nostri occhi come parte integrante del bagaglio culturale della società moderna, sulle quali la giustizia può esercitare la sua vigile supervisione, sono nate da forme di intemperanza oblativa: ospedali, banche, scuole, orfanotrofi non sono forse il sedimento istituzionalizzato di gesti profetici di misericordia, che oggi continuano a trovare forme innumerevoli di attualizzazione?
Per questo le teorie della giustizia più recenti e aperte sono pronte a riconoscere tale interazione profonda con l’orizzonte dell’amore misericordioso per il suo benefico influsso sulla qualità delle relazioni interpersonali15. Si apre a questo punto la possibilità di una circolarità virtuosa tra quella che Ricoeur ha chiamato la «poesia del religioso» e la «prosa della morale». Ogni attestazione di gratuità introduce un nuovo paradigma esemplare nel panorama della cultura e del costume dominanti, che innalza la sensibilità e l’unità di misura del giudizio morale. Nello stesso tempo il radicalismo della testimonianza personale possiede una carica di denuncia, che si manifesta attraverso comportamenti insoliti e atti di rottura, anche formalmente illegali, che in realtà aprono sempre nuovi orizzonti alla giustizia autentica16.
L’amore insegna quindi a «entrare» nell’ordine della giustizia, nel senso che lo promuove e lo dilata, ponendolo sotto l’egida del bene. Insegna però, contemporaneamente, anche a «uscirne»; insegna cioè a prendere le distanze dalle sue cadute formalistiche e legalistiche, quando la giustizia si rassegna ad assicurare una equità distributiva di superficie, consolidando lo scandalo intollerabile della disuguaglianza. Come ci ha ricordato Giovanni Paolo II nell’enciclica Dives in misericordia, «la giustizia da sola non basta e (...) anzi, può condurre alla negazione e all’annientamento di se stessa, se non si consente a quella forza più profonda, che è l’amore, di plasmare la vita umana nelle sue varie dimensioni» (DM, 12). Abbandonata a se stessa, senza la forza profetica della misericordia che le ricordi le sue mire universaliste e la richiami al primato del bene comune, anche la giustizia si rovescia nella più odiosa delle iniquità: «Summum ius summa iniuria».
|