
|
2009 - 19 giugno - 2010 - ANNO SACERDOTALE |
|
Don Ruggero Ramella sdfam, parroco(*) |

|
2009 - 19 giugno - 2010 - ANNO SACERDOTALE |
|
Don Ruggero Ramella sdfam, parroco(*) |
 Esperienza
di fraternità sacerdotale a Roma
Esperienza
di fraternità sacerdotale a Roma
Introduzione
Fin dai primi anni di seminario ho avuto nel cuore e nella mente la fraternità sacerdotale, mutuata da una felice esperienza pre-seminariale presso una comunità sacerdotale del Movimento dei Focolari: erano una novantina di sacerdoti provenienti da tutte le parti del mondo, c’era anche un vescovo in pensione, io solo ero un aspirante candidato al sacerdozio, capitato lì per caso, o meglio, per la provvidenza di Dio. Era una vera e propria "scuola sacerdotale", e tale era denominata ufficialmente, in cui, nella vita fortemente comunitaria nello stile dei Focolari, ognuno veniva aiutato a far crescere, rafforzare, e a volte rifondare il proprio essere sacerdote. Per me, che ero figlio unico, vissuto sostanzialmente da solo, pur avendo buoni rapporti con i miei coetanei, fu una bellissima e fortissima esperienza di vita umana, molto liberante, nonché una esperienza ecclesiale mai conosciuta, e soprattutto un’esperienza viva e inconsapevole del presbiterio. Lascio quindi immaginare che cosa ha significato per me, dopo sei mesi di questa full immartion ecclesial-presbiterale, entrare nella vita di un seminario "normale" e nella vita "solita" di una comunità, sia pure sui generis, quale appunto quella di un seminario.
Dopo un primo momento, in cui mi è sembrato di riconquistare la mia antica libertà individuale di quando vivevo praticamente da solo, ho percepito quasi subito il deserto reale di questa libertà ideale. Da allora ho cercato di rivivere e riprodurre in tutti i modi quell’antica esperienza vitale di comunità che vissi insieme a tutti quei preti, fedeli e fragili, robusti e bisognosi. Si susseguirono piccole esperienze, in seminario, nei primi anni di sacerdozio, con delusioni, abbattimenti, abbandoni, risollevamenti, per un ideale che non ha mai voluto morire, nonostante anche i miei tentativi di rifuggirlo. Alle difficoltà del vissuto si sono aggiunte quelle del fondamento teologico e spirituale, nonché del sostanziale fallimento storico dei tanti tentativi di fraternità sacerdotale: senza la pretesa di essere esaustivamente scientifici in questa sede, penso ai tentativi di S. Agostino, S. Eusebio da Vercelli, e di tanti altri, tentativi finiti tutti regolarmente nella vita religiosa strettamente intesa, come a dire, e come di fatto è stato, che la vita comune dei preti è appannaggio della vita consacrata, mentre il clero secolare si caratterizza, anche per le presunte esigenze pastorali, proprio per la sua vita individuale e solitaria, sia pure inserita in una comunità ecclesiale. A conforto di quanto vengo a dire riporto il giudizio che mi dette un professore, quando studiavo all’Università, a cui proposi il tema della vita comune dei preti per la mia tesina di licenza con un taglio storico: non ne vale la pena, mi disse, poiché finirà per ricavarne ben poca cosa a fronte di una lunga e faticosa ricerca.
Lasciando da parte per il momento la storia, ho comunque potuto nel tempo riflettere sui fondamenti teoretici a sostegno di una vita comune dei preti, di una fraternità sacerdotale oggettivamente riconoscibile, anche in relazione all’azione pastorale presbiterale; ho potuto così constatare che non ce ne sono, o meglio, non sono mai stati codificati, una volta individuati, anche con una serietà scientifica. Certamente oggi se ne parla di più, anche nei documenti ufficiali, e si fanno anche qua e là dei direttori o regole di vita in seno ai presbiteri di alcune diocesi, ma non si va più al di là di pie esortazioni, e spesso si calcano le ragioni psicologico-affettive, legate anche alla situazione contingente culturale di scarsa rilevanza del clero stesso nelle nostre società scristianizzate e molto secolarizzate, che fomentano un certo smarrimento e una qualche fragilità nel singolo sacerdote sempre più solo, senza un riconoscimento esterno del suo essere ed esistere funzionale. Questo approccio, sostanzialmente superficiale e contingente, alla problematica della vita comune del clero, porta ad una fondamentale inconsistenza degli argomenti e della stessa esperienza di fraternità, togliendole la veste di dignità oggettiva e universalmente valida, e relegandola piuttosto ad essere un fenomeno marginale, minoritario, ad appannaggio di gruppetti più o meno seriamente motivati, o peggio, nella considerazione di alcuni, e neanche pochi, a soddisfare il bisogno affettivo di pochi, magari gente non maturata sufficientemente, essendo ancora bisognosa dell’appoggio di altri.
A Roma
A Roma, la vita comune del clero è una cosa normale, anzi l’eccezione è esattamente il contrario: un fenomeno più unico che raro. Parroco, vicari parrocchiali e sacerdoti collaboratori vivono insieme, sotto lo stesso tetto, condividendo la mensa e anche una certa vicinanza umana. Questo, però, non vuol dire che ci sia una fraternità sacerdotale e una vita comune del clero, anche se non si può parlare di albergo semplicemente. Il vivere insieme, prima che una scelta, è un dato scontato, proveniente dalla consuetudine; non tutti lo vorrebbero, alcuni se ne sentono costretti, altri lo sceglierebbero di propria volontà, ma non nelle modalità imposte: infatti, l’andamento di ogni presbiterio è dettato di fatto dal parroco, che non sempre ha davanti agli occhi il perseguire la vita stessa comune e la fraternità dei sacerdoti, ma anzitutto la collaborazione pastorale, dove le altre cose possono essere al massimo funzionali ad essa. A volte il parroco, o anche qualcuno degli altri sacerdoti, vorrebbero una vita comune più accentuata in senso "more religiosorum", condividendo la preghiera per esempio, ben al di là della funzionalità pastorale. Altre volte ancora c’è la quasi totale trascuratezza del vivere comune, riducendosi ad un vivere insieme per caso, ma lavorando bene insieme. Altre volte non c’è né un minimo di vita comune, né una intesa pastorale. I più prendono atto, nella vasta gamma delle situazioni, con forti implicanze umane e psicologiche, anche al di là dello spirituale, della consuetudine, e vi si adeguano serenamente, apprezzandone il buono, perché comunque si tratta sempre di uomini religiosi e disponibili in genere, che se non sono amici, però possono essere temporanei compagni di strada ben disposti, oltre che colleghi collaborativi, e questo indifferentemente dall’età, dalla provenienza, dal ceto originario, dalla cultura personale.
Dentro questo tessuto comune ci sono poi diversi sacerdoti che vivono esperienze originali, o legate o ispirate a famiglie religiose o movimenti, che appunto vivono, contemporaneamente all’esperienza del presbiterio parrocchiale, una esperienza spiritualmente ed emotivamente più gratificante al di fuori non solo della parrocchia ma anche della stessa diocesi, riuscendo a volte a portare quell’input spirituale e di fraternità nel presbiterio della parrocchia, a volte a dividere la propria vita totalmente in due parti, in una sorta di distinzione tra lavoro e casa, dove la casa è fuori del presbiterio e del lavoro parrocchiali. Ci sono poi esperienze trasversali di pura amicizia umana, nate ai tempi del seminario, e che, per volontà soprattutto di qualcuno, riesce a vivere per decenni: una esperienza bella e soprattutto umana appunto, perché si riesce anche a tener fuori l’essere preti, anche se si concelebra insieme a volte la messa. Insomma, in tutta questa varietà di situazioni, ognuno può trovare molto, e spiritualmente, nonché sacerdotalmente, e anche umanamente, ma tutto questo frutto viene proprio, bene o male, da una vita comune del clero e da una certa fraternità sacerdotale, sia pure a volte offerte al minime, mentre altre volte riescono ad avere una cittadinanza se non piena certamente più scientemente considerata.
I fondamenti
Anche dopo questo excursus romano viene fuori ancora, dunque, il problema dei fondamenti teoretici della vita comune del clero e della fraternità sacerdotale. Speriamo, in un futuro non lontano, in qualcuno che si cimenti decisamente in questa impresa; nel frattempo mi azzardo ad avanzare alcune ragioni oggettive e necessitanti la vita comune del clero e della fraternità sacerdotale, non legandole, proprio per salvaguardarne la loro oggettività, al contingente e culturale ed esistenziale dei singoli sacerdoti collocati in questo nostro tempo.
Un primo fondamento è biblico: "Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri.
Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se avete amore gli uni per gli altri" (Gv 13,34-35), a cui fa eco la preghiera sacerdotale, "Perché tutti siano una sola cosa; come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch’essi in noi, perché il mondo creda che tu mi hai mandato…Io in loro e tu in me, perché siano perfetti nell’unità e il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li hai amati come hai amato me" (Gv 17,21.23). Noi preghiamo per l’unità dei cristiani, consapevoli che la divisione non è una testimonianza di Gesù al mondo, ma anche la qualità della comunione nelle nostre comunità va curata proprio perché ogni comunità esprima quella comunione evangelizzante il mondo, e tutti viviamo una certa qual frustrazione guardando alle nostre comunità e alla loro comunione di bassa lega spesso, una comunione al minimo, una comunione di là da venire, non solo nella sua pienezza ma anche in una certa sua maturità e dignità, senza contare l’assenza della massa cristiana, completamente estranea ad un discorso di coinvolgimento fattivo ed esistenziale in una comunione delle proprie rispettive comunità, assenza che non fa certo bene alla comunione, e non solo per la sua assenza di bene.
Passiamo il discorso della comunione evangelizzante al presbiterio, secondo anche il dato biblico sopra ricordato, e allora appare evidente la necessità, a maggior ragione, di una comunione anche fra i presbiteri, e non di una comunione al minimo di sopravvivenza, perché, se coloro che presiedono alla comunione sono allo stesso livello delle loro comunità, allora non c’è che poca speranza di un avanzamento di un certo rilievo della comunione evangelizzante della stessa Chiesa. La comunione è il fondamento evangelizzatore, e non i vari metodi più o meno al passo con i tempi. Di qui la necessità di essere capaci da parte dei preti di comunione anzitutto tra loro, visto che Gesù parla anzitutto agli Apostoli, e visto che comunque hanno la responsabilità ultima della comunione e dell’evangelizzazione anche in questi nostri tempi attuali. I preti sono chiamati a presiedere la comunità e quindi la comunione, e quindi essi per primi la debbono vivere, e anzitutto con coloro che ne condividono in primis la stessa responsabilità. La comunione, sappiamo, non è solo l’unità generica di intenti, non solo l’unità della dottrina, ma essa passa anche nel segreto dei cuori, dove alberga l’Amore di Dio che ci ha raggiunto in Gesù Cristo, per viverlo noi stessi in prima persona, fedeli al mandato che "se Dio ci ha amati, così anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri" (1 Gv 4,11). Questa comunione ideale, ma non idealistica, la si vive concretamente nella vita quotidiana con gli altri uomini, che per noi sacerdoti sono anzitutto i nostri confratelli, specialmente quelli con cui viviamo provvidenzialmente insieme, e questo anche prima dei nostri stessi parrocchiani, come del resto questi ultimi vivono la loro esperienza di comunione anzitutto con la propria famiglia, con cui vivono sotto lo stesso tetto: non cadiamo nel generico, nella comunione vissuta con tutti e con nessuno; si vive la Chiesa universale vivendo calati nella Chiesa locale, e a sua volta nella comunità parrocchiale, ed infine nelle relazioni della propria cerchia: è una comunione a cerchi concentrici, in cui la verità efficiente ed efficace della comunione, vissuta nelle relazioni più ravvicinate, si proietta negli altri livelli di comunione, strappandoli così alla genericità, a cui sarebbero condannati a causa delle dimensioni che sfuggono al controllo reale della singola persona, e quindi all’efficacia reale dell’azione della singola persona su di essi. Il sacerdote è un uomo uguale agli altri uomini, e quindi soggetto alle stesse esigenze psico-affettive di tutti gli altri uomini, e quindi anche lui, benché celibe, ha bisogno di relazioni ravvicinate, soprattutto con coloro che per statuto sono a lui più vicini, ossia gli altri sacerdoti, suoi confratelli, ossia fratelli due volte, per il Battesimo e per il Ministero sacerdotale. Il presbiterio è la famiglia del sacerdote, ed è lì che egli vive le relazioni dove si gioca l’autenticità della comunione da vivere a tutti i livelli sopra descritti; già i parrocchiani sono fuori di quella cerchia ristretta della sua famiglia, sono parte di quel livello più grande che presuppone il livello primario delle relazioni più ravvicinate, ossia delle persone che vivono insieme, non per caso, ma per un qualcosa che hanno fortemente in comune, il Sacerdozio, appunto.
Quest’ultima annnotazione collega la motivazione biblica direttamente al fondamento sacramentale: l’Ordine costituisce in una particolare unità tutti i sacerdoti tra loro, secolari o religiosi che siano, e questa verità sacramentale ha la stessa forza della verità sacramentale dell’unità dei cristiani che è frutto del Battesimo. E’ un secondo titolo di unità e di comunione, che ha bisogno della verità del vissuto con tutte le conseguenze pratiche, come nel Battesimo, e che con tutte le sue esigenze deve essere tradotto nella verità della vita, in primis l’unità e la comunione di tutti i fratelli, essenziali per l’evangelizzazione, come per l’efficienza dello stesso Sacerdozio. Anzi il Sacerdozio è anzitutto a servizio proprio di questa comunione e di questa unità di tutto il popolo di Dio, in modo da rendere tutti capaci di dare il proprio contributo, anzitutto di comunione, col mettersi al servizio, facendosi dono, ciascuno con le proprie potenzialità, poiché l’amore è finalmente concreto.
Se ci fermassimo a considerare seriamente il compito sacerdotale del singolo sacerdote, soprattutto guardando all’efficienza, in relazione particolarmente alla comunione e alla unità dei nostri fedeli, ci sarebbe solo che da tremare, e ogni sacerdote lo sa bene, conoscendo lui stesso anche le sue fragilità e i suoi peccati. Il ministero sacerdotale è un compito sovrumano, considerato che tratta di cose non semplicemente terrene ma che sfociano direttamente e viaggiano anzi nell’eterno. Abbiamo continuamente bisogno di supporto da parte di coloro che, condividendo il nostro stesso ministero, possono capirci fino in fondo, riparando anche le nostre fragilità ed errori con la loro efficienza e robustezza, e viceversa, in modo che il nostro personale rallentamento non sia a nocumento del popolo di Dio in maniera inesorabile e irreparabile, e la coscienza di esso non schiacci il singolo sacerdote. Insomma, per fortuna che siamo così legati tra noi sacerdoti, altrimenti ne andrebbe di mezzo persino la nostra salvezza: la carità, invece, che possiamo esercitare con la connotazione della misericordia degli uni per gli altri, sta alla base della speranza e della riuscita del nostro personale sacerdozio e nella possibilità seria di un raggiungimento della stessa salvezza personale e financo la santità. Tutto ciò è, indipendentemente dal grado di autocoscienza che ciascuno di noi ha di esso: a maggior ragione è allora necessario che diventi sempre più viva, in ciascun sacerdote, la coscienza del formidabile peso del ministero per una singola persona e dell’altrettanto formidabile aiuto che ci viene dal condividere essenzialmente ed esistenzialmente con altri il Sacerdozio, e questo non in astratto ma nello spicciolo esigente del quotidiano. Una fraternità sacerdotale e una vita comune reale del presbiterio è così necessaria non solo per l’origine biblica ma anche per la verità essenziale ed esistenziale che ne discende, e che ancora una volta ci fa toccare con mano come la Parola di Dio è veramente fonte di vita reale, quella che si snoda nei giorni e negli anni della vita di un qualsiasi uomo.
Un ultimo argomento fondante della vita comune del clero e della fraternità sacerdotale proviene dall’osservazione del tempo presente, che rende, al di là del contingente, più urgente e necessario sottolineare il pericolo non semplicemente ipotetico in tutti i tempi della solitudine del prete, e questo non solo in riferimento al celibato, ma anche alla sublimità del sacerdozio stesso, benché caricato sulle spalle fragili di un uomo. Viste le enormi smagliature della comunione ecclesiale a tutti i livelli (basta fermarsi alle realtà parrocchiali con serenità e realismo), e anche all’interno dello stesso presbiterio (spesso una somma di buoni individui), che riflettono gli strappi enormi del vissuto sociale attuale, a cui c’è ancora un po’ di rimedio in seno alle famiglie, sia pure sfasciate e ricomposte malamente, il singolo sacerdote, come il singolo cittadino, è lasciato a se stesso ed in braccio alle sue sole forze, che difficilmente possono reggere a lungo in una situazione di solitudine esistenziale, a nocumento e della stessa persona del sacerdote e dello stesso sacerdozio, nonché della comunità stessa. Solo nella Chiesa e solo nella società civile, il prete è alla continua ricerca delle modalità del suo ministero per farsi accettare dalla società circostante, costringendosi a snaturare il suo stesso sacerdozio, andando appresso a quello che gli chiede inopinatamente il mondo, che non conosce la sua verità, anche perché egli stesso, il sacerdote, spesso non l’ha chiara neanche lui, a causa della confusione che periodicamente prende la Chiesa, che subisce le crisi del mondo in cui vive, delle stesse culture e delle stesse civiltà al tramonto, perdendo di vista l’essenziale, assumendo le logiche del mondo, adeguando ad esse le esigenze evangeliche, sostituendo, sia pure in buona fede, l’antica religione con la religione nuova dei valori. Chi e cosa ci salverà dalla continua tentazione che ci viene dal mondo e che di tanto in tanto crea confusione e scompiglio nelle file ecclesiali, nonché ecclesiastiche? La risposta è la comunione, la fraternità vissuta con gli stessi sentimenti di Cristo, in modo da mantenere la lucidità anche quando tutto intorno è confusione, sì da essere utili a tutti ad intra ed ad extra, assolvendo al compito della Chiesa di essere anticipo e guida delle realtà future a cui tutti gli uomini, fatta salva la loro libertà personale, sono finalmente chiamati. "Voi siete il sale della terra; ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo si renderà salato? A null’altro serve che ad essere gettato via e calpestato dalla gente" (Mt 5,13), ci ricorda Gesù stesso. La risposta vale per tutta la Chiesa, a maggior ragione per il Presbiterio e per i singoli sacerdoti: da soli soccomberemo con tutti gli altri uomini, insieme ci salveremo con tutti gli altri uomini, anche grazie al nostro preziosissimo contributo, quali sacerdoti nell’unico Sacerdozio di Cristo Sacerdote.
Un’esperienza di fraternità sacerdotale
La passione per i preti è stata sempre presente nella mia vita sacerdotale e presacerdotale, come già detto all’inizio di questo scritto, così infine questa passione mi ha portato all’incontro con il carisma dell’Amore Misericordioso di Madre Speranza, ed in particolare con la Congregazione dei Figli dell’Amore Misericordioso, in cui l’antico ideale personale trovava finalmente una sua oggettività e una forza cha da solo non avevo mai sperimentato, lasciandomi infine in uno stupore, e in una sicurezza granitica, che quello che sentivo da decenni non fosse una mia follia giovanile con cui non avevo mai fatto pace, ritardando magari la mia crescita psico-affettiva e umano-sacerdotale. Qui ho imparato come la vita comune, e comunque una qualsiasi forma di fraternità sacerdotale, sia la medicina per tanti malesseri del sacerdote, contemporaneo in particolare, e anzi la prevenzione migliore; qui ho sviluppato il mio impulso spontaneo a prendermi cura dei sacerdoti, quale specifica missione dei Fam; di qui anche la qualità migliore della fraternità offerta a tutti, preti e seminaristi, nella mia parrocchia. Non si tratta, infatti, di attirare altri ad entrare nella Congregazione quali sacerdoti diocesani con voti, uno dei 4 rami dell’Istituto religioso, di cui faccio parte, per vivere la vita comune e la fraternità sacerdotale, ma piuttosto, con la forza del carisma Fam, fomentare la fraternità sacerdotale dall’interno del vissuto di ogni singolo sacerdote, là dove egli vive nel suo presbiterio, tanto più che a Roma non c’è bisogno di cercare qualcuno con cui convivere, perché già ci sono i confratelli che vivono con te: si tratta invece di qualificare questo nostro vivere insieme in chiave di fraternità e di vita comune del clero, e il sacerdote diocesano Fam è chiamato ad aiutare per questa qualificazione, in particolare il clero più giovane, ma non solo ovviamente, anzi il clero più giovane spesso, per le sue giovanili sicurezze, è il più refrattario rispetto all’adulto, che invece proviene da tante disincantate esperienze della vita e umana e sacerdotale, e che non disprezza più, come forse una volta, una casa per sé e per un suo più valido ministero.
Non tutti possono avere la vocazione sdfam, ma ogni sacerdote si deve sentire interpellato dalla vocazione alla fraternità per tutte le ragioni che ho via via summenzionato, anzi, direi, che la fraternità sacerdotale è intima allo stato sacerdotale almeno quanto il celibato, se non di più, vista la sua origine sacramentale, ma per un curioso evolversi delle cose umane ci ritroviamo davanti ad una legge ecclesiastica per il secondo, benché erroneamente sentita a volte imposta, mentre nulla obbliga alla vita comune e alla fraternità, che invece sarebbero alquanto necessarie per vivere equilibratamente lo stesso stato celibatario, che è più intimo alla fraternità sacramentale dei preti più di quanto dica la legge, che al di là dell’ideale, da perseguire sempre, deve comunque fare i conti con la realtà della fragilità e anche di tanta immaturità affettiva, specialmente in questi nostri tempi crepuscolari generanti tante solitudini. Anzi, direi, che il criterio comunitario, la propensione o meno alla fraternità e alla vita comune, dovrebbe essere inserito nella verifica vocazionale fatta nei seminari, dichiarando guerra al libero professionismo, forma più elegante del medioevale di tutti i tempi clericus vagans; siamo infatti, noi sacerdoti, un unico corpo, e non dei liberi battitori, senza voler mortificare per questo i carismi di ognuno, che però in alcuni si rivelano decisivi per scollegarsi di fatto dalla propria chiesa locale e dall’obbedienza al proprio ordinario, magari facendo però furore sulle piazze e le tribune sempre pronte ad accogliere il carisma particolare di turno, confortandoci con un "c’è posto per tutto e per tutti nella Chiesa", come del resto è spesso evidente nel bene e nel male.
Nel mio presbiterio parrocchiale, che non ha ovviamente una regola esterna, si cerca di vivere qualitativamente il nostro stare insieme non per caso, ma certamente non scelto, almeno riguardo alle persone, ma anche per lo stesso stare insieme: non viviamo ognuno con la stessa idea ed intensità la nostra vita comune, anzi convivono forti spinte centrifughe e a volte difficili combinazioni tra vita personale, presbiterio e ministero, ma, vuoi per la volontà del sottoscritto a riguardo di un minimo di vita comune, vuoi per il piglio umano sempre del sottoscritto, vuoi per un coacervo comunque di attenzioni reciproche, che danno un minimo di parvenza di un clima, se non familiare, perlomeno di una certa simpatia e, forse, amicizia umana, vuoi anche per convenienze ragionevoli che non richiedono compromessi lesivi della propria libertà e dignità, vuoi perché fa sempre più piacere parlare con un essere umano piuttosto che col muro, specialmente quando si risale su in casa dal lavoro del ministero per il pasto, specialmente la sera (e magari vedere anche insieme un film, perché no?, tirare fino a tardi di tanto in tanto chiacchierando piacevolmente, magari intorno ad un bicchierino, nel silenzio riposante della tarda serata e del primo sonno della città, parlando finalmente non solo di lavoro, ma di cose anche indifferenti, trovando infine, a volte, anche il tempo di aprire il proprio cuore all’altro, confidando il proprio dolore, sapendo, nella sicurezza che nasce dalla consuetudine del vivere insieme, condividendo anche le cose banali del quotidiano, che quel mio segreto sarà custodito anche con affetto, che nasce dalla confidenza pure, e questo anche al di là dell’età, delle idee, magari non collimanti, ma che fa scoprire la persona, non solo un prete collega, magari superiore, fa scoprire l’uomo, fa intravedere un amico, che resta anche oltre l’esperienza dello stare insieme per quell’ufficio). Ne giova anche la conduzione della comunità stessa, che avverte l’unità articolata del suo presbiterio, quando esso è animato da logiche superiori, che non disdegnano il buon senso delle buone leggi della natura: avvertono che c’è anche un Vangelo che non è astratto, ma che si impasta saggiamente con la vita, come intravede mediante anche l’esperienza dei suoi pastori. Pastori che riescono persino a pregare insieme, benché non ci sia nulla che ci obblighi a ciò, visto che non siamo niente di più, formalmente almeno, che coinquilini che stanno lì esclusivamente per un lavoro comune.
Soprattutto, sottolineo il nostro prenderci cura l’uno per l’altro, a partire dal sottoscritto, in prima linea sempre su questo, e sul resto, per attitudine ormai atavica e ora anche per il carisma Fam. Noi lo facciamo nel nostro piccolo, specialmente nei momenti di difficoltà, come malattie, lutti, contrarietà e personali e sul lavoro, accorgendoci delle pieghe diverse dal solito del viso, a partire dalla mattina quando ci si incontra intorno al caffé; lo facciamo anche con la cura e il rispetto per le abitudini altrui, per i vezzi anche, per i simpatici difetti, come per quelli seri pure, anche quando non si può fare nulla, nonché per le preferenze anche quelle banali, come per le intolleranze spesso molto personali, viste con la logica del tipo, "se so che una cosa ti da fastidio perché infastidirti inutilmente?"; saperci ridere, ma saperci anche rispettare, imparando i codici personali del linguaggio di ognuno, espressi da atteggiamenti sconosciuti agli estranei di questa strana convivenza, forse fraternità sui generis.
Dovrebbe essere un discorso più ampio questo, dovrebbe coinvolgere il vescovo stesso, il quale, avendo il coraggio di stabilire una scala di priorità della sua azione e dei suoi interessi, dovrebbe mettere avanti a tutto e tutti, compresi i fedeli, le singole persone dei suoi preti, facendo seguire tutto il resto dopo, compresa l’occupazione di tutti i quadri. Anzi, il vescovo per primo dovrebbe fomentare una qualsiasi forma di fraternità e anche di vita comune del proprio clero (magari convivendo in qualche modo egli stesso con qualcuno dei suoi preti), e non a colpi di decreti, ma piuttosto con quell’approccio umano, ricco della misericordia di Dio, sopra menzionato: è una strada lunga, di cui spesso non se ne raccolgono i frutti subito o nel giro di un tempo ragionevole, misurabile piuttosto col tempo lento di ogni uomo, e quindi di ogni prete, come ci suggerisce la condotta paziente e longanime di Dio stesso, ma è appunto l’unica seria e fruttuosa in senso totalmente pieno, perché porta a stabilire come strategia pastorale che la comunione in sé è l’annuncio e la guida, nonché la comunione reale, quella che nasce dal connubio felice del meglio dell’umano con il Vangelo in toto, poiché la comunità-comunione reale è quella che dice al mondo che è possibile un nuovo mondo già ora e qui: quale migliore annuncio del Vangelo? Altro che strategie cerebro-cervollotiche, socio-filosofiche, senza anima e senza cuore, e infine senza testa. Forse bisogna seriamente pensare ad una nuova strategia pastorale per i tempi attuali e futuri con nuovi modelli di pastori che presiedono alle comunità con una effettiva comunione di vita nel proprio presbiterio in prima persona: come essere maestri e guide di comunione se poi per primi non viviamo la reale esistenza comunionale, che si consuma nel realismo prosaico delle relazioni quotidiane ravvicinate, ed affettivamente equilibranti e stabilizzanti anche le proprie persone ed il vissuto sia pubblico che personale?
Chi vive una autentica vita di fraternità, voluta e non semplicemente per istituzione, sa le ricadute sulla propria comunità, perché lo sforzo che il presbiterio tutto fa nel guidare alla comunione piena tutti i membri, della comunità parrocchiale nella fattispecie, e supportato dalla verità del contenuto insegnato ed esortato perché vissuto dai propri stessi pastori, così diversi, ma così impegnati, in prima persona, spinge i fedeli a vivere quella comunione che è alla base di qualsiasi autentico ed efficace annuncio del Vangelo. Questo cerchiamo di fare nel nostro presbiterio, al di là del risultato ed anche delle nostre innumerevoli fragilità e mancanze, mie innanzitutto, questa è l’esperienza che noi facciamo di fraternità sacerdotale a Roma: una esperienza non ingenua, ma faticosa, sofferta, seria, pensata, fondata, voluta e proposta infine ai nostri confratelli, sicuri di dare un contributo alla vita e al ministero dei tanti sacerdoti che vivono nella nostra città, e non solo. E’ vero che per ora sono l’unico sacerdote diocesano Fam a Roma, ma il contributo che posso dare con la nostra esperienza può giustificare abbondantemente l’essere di questa mia bellissima vocazione, di cui non finisco mai di ringraziare il Signore, che ha messo nel mio cuore tanto amore misericordioso per i preti.
(*)
"Don Ruggero Ramella, sacerdote dal 1984 della Diocesi di Roma, è parroco dal 1995 a SANTA MARIA STELLA MATUTINA, a Roma nella zona di Monte Mario; una parrocchia di 7.000 anime. Collaborano con lui come vicari parrocchiali altri due sacerdoti romani e un sacerdote colombiano, laureando alla Gregoriana. Dal 2005 ha conosciuto la Congregazione dei Figli dell’Amore Misericordioso e l’8 febbraio 2008, pur rimanendo sacerdote diocesano di Roma, ne è divenuto membro, avendovi emesso la prima professione come sacerdote diocesano con voti.
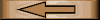 |
|
[Home page | Sommario Rivista]
realizzazione webmaster@collevalenza.it
ultimo aggiornamento
23 febbraio, 2010