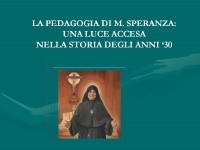
LA PEDAGOGIA DI M. SPERANZA: UNA LUCE ACCESA
NELLA STORIA DEGLI ANNI ‘30
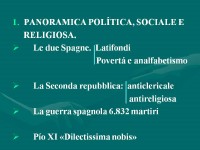 PANORAMICA POLITICA, SOCIALE E RELIGIOSA
PANORAMICA POLITICA, SOCIALE E RELIGIOSA
Per capire bene
l’importanza dell’opera educativa di Madre Speranza Alhama Valera nella
Spagna degli anni ‘30, bisogna avere una visione, almeno generale, della
situazione storica, socio-economica ed educativa che viveva la Spagna della
prima metà del XXº secolo.
Non vorrei dilungarmi
sull’aspetto
storico, ma credo necessario fare alcuni accenni a
questa situazione perché possiate capire l’enorme servizio sociale e nello
stesso tempo misericordioso, che Madre Speranza svolse a favore dei più
piccoli e bisognosi, i poveri , soprattutto dei bambini, dei
giovani e delle loro famiglie.
Nel periodo che va
dal 1920 al 1950 possiamo dire che esistevano due Spagne molto diverse:
-
Una Spagna idealizzata,
romantico-nazionalista, sostenuta dai mandatari, propria della nobiltà,
e da una plutocrazia industriale, formata da i pochi ricchi.
-
Un’altra Spagna, più numerosa, povera e
disorganizzata, quella del popolo; caratterizzata da un grave problema
agrario-latifondista, e da uno sviluppo industriale scarso e retrogrado.
Il 14 aprile del 1931
il re Alfonso XIIIº capì che il suo regno era finito e partì per l'esilio.
Quello stesso giorno alle 18,45 fu proclamata la IIª Repubblica Spagnola.
Così dall'aprile 1931 al luglio 1936 (5 anni) si ebbero ben ventinove
governi con 10 diversi Presidenti, col predominio tanto della destra come
della sinistra, sino ad arrivare, durante la guerra civile, alla dettatura
del proletariato. (
Eduardo Mendoza,
Riña de Gatos)
Molti intellettuali
alzarono la loro voce contro il caotico regime politico, ma dovettero
abbandonare la Spagna ed intraprendere la via dell’esilio; fra loro: lo
scrittore Miguel de Unamuno, il filosofo Ortega y Gasset, il medico Gregorio
Marañón, il pedagogo Fernando de los Ríos, il poeta Antonio Machado, e tanti
altri.
Il programma tentato
dagli uomini della IIª Repubblica era molto ambizioso comprendeva: la
europeizzazione del Paese, la liberalizzazione dell'insegnamento, una
maggiore attenzione alle rivendicazioni operaie. Ma, naturalmente, questo
tentativo di riforma trovò come oppositori i latifondisti, quasi tutti
nobili, i finanzieri e gli industriali. Combattere queste forze e nello
stesso tempo procedere alla riforma dell'esercito e dell'Amministrazione
dello Stato era un compito molto superiore alle possibilità dei partiti
repubblicani; molto di più se si considera che, per la loro violenta
aggressione ai principi religiosi del popolo, si alienarono le simpatie
delle classi medie e della maggior parte del popolo. La società spagnola si
divise in due settori definitivamente avversi: quello dell'"ordine" e quello
della "rivoluzione".
Altri problemi che
doveva affrontare la Spagna dell’inizio del secolo XX° erano: la mortalità
infantile - molto superiore alla media europea - e l’immigrazione verso le
grandi città.
Tra il 1.900 e il
1950, alcune città come Madrid, Bilbao, Oviedo e San Sebastiano triplicarono
la loro popolazione. Queste moltitudini, che riempivano le città, erano
stata spinte dalla miseria e dalla fame ad abbandonare i campi e portavano
in fondo al cuore il risentimento e l'odio verso le classi privilegiate (Cf.,
I Santi Innocenti di Miguel Delibes).
La IIª Repubblica e la
religione
L'atteggiamento della
IIª Repubblica nei confronti della religione fu veramente
contraddittorio, perché, sebbene da una parte manifestava la più completa
neutralità al riguardo (l'articolo 3° diceva esattamente: "Lo Stato spagnolo
non ha una religione ufficiale"); dall'altra cercò di portare avanti una
politica anticlericale e antireligiosa, in evidente contrasto con i
sentimenti religiosi della popolazione, nella sua quasi totalità cattolica.
Infatti, abolì molte Congregazioni religiose, perché, a giudizio dei
governanti "potevano costituire un pericolo per lo Stato".
Le Congregazioni
rimaste in vita furono considerate delle "associazioni", soggette ad un
particolare statuto, che fu pubblicato nel 1933. Secondo questo statuto
tutte le Congregazioni dovevano presentare annualmente allo Stato il conto
esatto delle entrate e delle uscite. L’articolo 26 sopprimeva il contributo
dello Stato ai sacerdoti e proibiva al clero, regolare o secolare,
l'esercizio dell'industria, del commercio e dell'insegnamento. L'articolo
concludeva dicendo che tutti i beni delle Congregazioni religiose potevano
essere nazionalizzati..
Pio XI nella sua
enciclica "Dilectissima nobis", rendeva note tutte le vessazioni subite
dalla Chiesa in Spagna, e le paragonava con quelle subite in Messico e in
Russia.
Dalla persecuzione
delle idee a quella delle persone il passo fu breve. Il 15 aprile 1936 Calvo
Sotelo, nell'assemblea di "Las Cortes", dichiarava che dal 16 febbraio al 2
aprile si erano incendiate, insieme ad altri stabilimenti pubblici e
privati, 36 chiese. Una raffica di sangue e di furore si era scatenata sulla
Spagna, producendo, in appena un mese e mezzo 345 feriti e 74 morti. Questo
numero di martiri crebbe durante la guerra civile del ’36. Le vittime
religiose arrivarono a 6.832, tutte loro nel territorio repubblicano, fra le
quali 13 vescovi, 4.184 sacerdoti, 2.365 religiosi e 283 religiose.
Il professore J.
García Carrasco interpreta così questo attacco alla Chiesa:
"La rabbia degli
anarchici spagnoli contro la Chiesa è la rabbia di un popolo
intensamente religioso che si sente abbandonato e deluso. I preti e
i frati lo avevano abbandonato in un momento critico della sua
storia per buttarsi in braccio ai ricchi... Perciò quando si
lanciarono alla lotta per la loro utopia cristiana, non fu con la
Chiesa, ma contro di essa. Persino la stessa violenza può essere
qualificata come religiosa"
Vedremo come la Madre
ha una concezione molto simile.
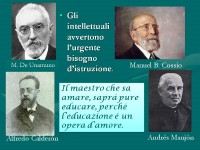 Situazione educativa
Situazione educativa
I fini educativi in
quell'epoca riflettevano uno spirito classista, opposto
all'aspirazione, oggi generalizzata, di democratizzazione dell'insegnamento.
Esisteva una scuola
che godeva di grande prestigio, portata avanti dagli ordini religiosi, tanto
che gli stessi uomini di Stato che si professavano laicisti, affidavano
l'educazione dei loro figli ai religiosi. Lo stesso Salvador Madariaga
affermava che "l'opera maestra della Chiesa in Spagna è stato lo sviluppo
di un grande sistema di insegnamento". Ma il problema della scuola
cattolica, oltre all’opposizione da parte del Governo, era il suo costo.
Non aveva, infatti, nessun contributo
dall’Amministrazione, e purtroppo era inaccessibile alle classi popolari.
Bisognava far fronte
alle necessità educative di una società spagnola di 18 milioni di abitanti,
dei quali quindici e mezzo erano braccianti agricoli, e duecento sessanta
mila veramente poveri.
Nel 1920 la Spagna
contava il
52,2 % di analfabeti, la diminuzione rispetto all'anno
1875 era stata dello 0,38%. Secondo le statistiche ufficiali nel 1925
mancavano nella Spagna 10.148 scuole; numero probabilmente molto maggiore
considerando che l’informazione proveniva dallo Stato. Soltanto a Madrid
20.000 bambini in età scolare erano privi di scuola, e molte di esse non
meritavano tale nome.
Uomini di grande
influenza nel mondo culturale, come Unamuno, rilevarono il bisogno
urgente d’istruzione e la necessità di sopprimere questo classismo culturale
esistente nella nazione spagnola. Diceva:
"La nostra società
presenta, rispetto al sapere, le stesse disuguaglianze che nelle terre,
giacché, insieme ad una minoranza di grandi ricchi c'è una moltitudine
immensa di bisognosi; [...]. Ci sono molti che ancora non sanno nemmeno
leggere, altri è come se non sapessero, e poi un piccolo gruppo di isolati
in se stessi, che divorano idee che non possono restituire, consumando
eccessivamente e senza produrre... quelle intelligenze profonde e tenaci che
corrono senza profitto per il prossimo... potrebbero costituire la base
ferma della ricchezza spirituale e della fraternità patrie.
Per questo, c'è bisogno soltanto di un soffio
d'amore capace d’ incanalare le energie oggi disperse, e la convinzione
che non si tratta soltanto di un’opera di misericordia, ma di un dovere di
giustizia, insegnare a chi non sa".
Per Unamuno gli
intellettuali dovevano essere maestri del popolo giacché il monopolio e il
lusso della scienza è una maledizione; "inaridisce i cuori e spegne in
essi la luce della speranza, della carità e della fede".
Giner de los Ríos
auspicava per i maestri una formazione "capace di svegliare nelle loro
anime ...l’ amore a tutte le grandi cose, alla religione, alla natura,
all'arte; una coscienza trasparente per le cose nobili, dignità nei modi,
semplicità, sobrietà, tatto, e infine, quello spirito di educatore che è
capace di rimuovere, come la fede, le montagne, e che porta nel suo seno,
forse come nessun altro, l'avvenire dell'individuo e della patria".
Manuel B. Cossìo
in una conferenza tenuta all'Ateneo di Madrid si lamentava cosí:
"Bisogna essere
profondi nella vita, e se andiamo in profondità vedremo che non significa
avere delle scuole primarie, le 27.000 mal contate che abbiamo, nelle
condizioni che tutti conosciamo, quando per la popolazione spagnola ci
vorrebbero 100.000 ... Si dice che abbiamo dei programmi, e dei programmi
completi, in realtà nei nostri programmi appaiono le applicazioni tecniche,
il canto, la ginnastica, tutto ciò che si possa desiderare, ma voi sapete
che tutto questo nelle nostre scuole, almeno nella loro maggioranza, non
esiste... [Si dice che abbiamo scuole materne e non arrivano a 500 in tutta
la Spagna; che abbiamo scuole per adulti, e funzionano tre, quattro, tutt'al
più cinque... ]Dei locali meglio non parlare. Non si è forse detto
nell'assemblea degli ispettori che ci sono delle scuole in cui il feretro
viene deposto proprio sulla cattedra del maestro prima del funerale?".
Alfredo Calderón:
"Io credo con Giner, con Unamuno e con tutti coloro che qui sanno pensare
e sentire rettamente, che il problema della Spagna è un problema pedagogico,
e che la rigenerazione della patria deve venire dalla scuola".
Andrés Manjón "I
nostri mali provengono in gran parte dall'ignoranza, siamo cattivi perché
non ci è stato insegnato ad essere buoni... l’apatia, la freddezza,
l'indolenza e la trascuratezza sono stati gli insegnamenti che abbiamo
ricevuto".
Madre Speranza
non è un’intellettuale, ma una donna pratica che capisce bene il momento
storico in cui vive e la necessità di mettere in pratica tutte queste idee
perché diventino una realtà.
Ciò che di Lei ci
lascia veramente perplessi è la chiarezza di vedute sulla reale situazione
sociale e politica della Spagna in quel 1931; la causa, anche secondo Madre
Speranza, era da attribuire all'ignoranza e alla miseria delle classi umili,
che le rendeva utili strumenti nelle mani dei politicanti e degli anarchici.
Ella va ancora più in
là degli intellettuali e prevede un futuro oscuro:
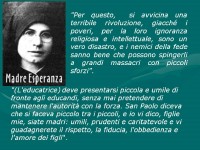 "Per questo, si
avvicina una terribile rivoluzione, giacché i poveri, per la loro ignoranza
religiosa e intellettuale, sono un vero disastro e i nemici della fede sanno
bene che possono spingerli a grandi massacri con piccoli sforzi".
"Per questo, si
avvicina una terribile rivoluzione, giacché i poveri, per la loro ignoranza
religiosa e intellettuale, sono un vero disastro e i nemici della fede sanno
bene che possono spingerli a grandi massacri con piccoli sforzi".
La visione cristiana
della vita porta Madre Speranza a vedere con chiarezza che il desiderio di
Dio, è contribuire a creare una società nuova, più umana, giusta, cristiana,
e i religiosi dovevano contribuire a questo.
"Sembra, figlie
mie, che i profondi colpi della giustizia divina avrebbero dovuto
commuoverci profondamente, ma, purtroppo, non è stato così, anzi, siamo
convinti che soffriamo un martirio o castigo immeritato, se non imposto. E
con questo, lungi dal disarmare il braccio della giustizia divina, noi
religiosi lo obblighiamo a mandare nuovi flagelli".
Proponeva, perciò, ai
Religiosi, soprattutto alle Ancelle da lei fondate, di rimanere accanto ai
poveri, dando una testimonianza eroica con la loro presenza; mentre con la
fuga, diceva, niente di buono si poteva ottenere e si sarebbero perse molte
occasioni di fare del bene.
"E' doloroso
vedere come, in questi tempi di lotta, molti Religiosi pensano solo a come
potrebbero scampare il pericolo... Chiediamo invece al Signore che ci dia il
coraggio e la forza di non vergognarci... di apparire come amici suoi e che
con tenacia sappiamo difendere la Gloria divina e siamo disposte a soffrire
tutto, senza omettere di insegnare al bambino l'amore che deve a Dio, e che
si abitui a vedere in Lui un Padre pieno di bontà... E' arrivato il momento
di darci pienamente all'esercizio della carità, e in questi momenti sarà un
omaggio di fede e di fiducia alla Divina Provvidenza".
 L’interpretazione
sociale e l’opera della Madre Speranza
L’interpretazione
sociale e l’opera della Madre Speranza
Fin dall’anno 1927
aveva sentito la voce del Signore che la spingeva a diffondere la dottrina
dell’Amore Misericordioso, quindi volle offrire la sua vita e tutta la sua
attività per rendere manifesta la misericordia di Dio in mezzo a quella
enorme confusione politica, sociale e pedagogica della sua epoca.
La sua risposta non
si fece aspettare e la notte di Natale del 1930 fonda a Madrid la
Congregazione delle Ancelle dell’Amore Misericordioso, e il 14 aprile del
1931, lo stesso giorno in cui veniva proclamata la 2ª Repubblica,
caratterizzata dalla sua antireligiosità, apre il primo collegio e commenta:
"Quando gli uomini vogliono cacciare Dio dal mondo per odio, Lui vuole
rimanere nel mondo per amore".
Madre Speranza fa un
analisi dei problemi del suo tempo con uno stile puramente evangelico. Lo
stesso stile che Cristo ci insegna nelle parabole della misericordia.
Pensiamo alla parabola del Buon samaritano;
Madre Speranza
|
1. Lo vide
|
vede il bisogno
del suo popolo. |
|
2. Sentì compassione di lui.
|
Sente
compassione, amore e misericordia per questo popolo immerso
nell’ignoranza. |
|
3. Si avvicinò
|
Si avvicina ai
poveri e ai bisognosi |
|
4. Curò le sue ferite.
|
Coprì le loro
necessità più urgenti: amore, pulizia, cibo e istruzione.
|
|
5. Lo caricò su di sé e lo portò in una locanda.
|
Crea dei centri,
con uno stile proprio:
- Spirito di famiglia, dove le suore
debbono essere delle vere madri per gli allievi.
- in un clima di amore, di gioia e
di, affabilità
- ed offre un’ educazione integrale
che arrivi a tutti gli aspetti della persona.
|
Senza risorse
economiche, ma con una fiducia assoluta nella Provvidenza e la certezza che
era questa la volontà di Dio, la Madre Speranza dispiega un’attività
sbalorditiva:
-
All' apertura del primo collegio il 14 aprile
del 1931 seguì a giugno dello stesso anno quello di Alfaro. Nella
provincia di Logroño, acquistò un gran palazzo che disponeva di 150
stanze, un gran piazzale e un orto; qui si aprirono un collegio convitto
ed una scuola, per dare la possibilità ai bambini esterni di
frequentarla insieme con gli interni.
A queste prime
fondazioni ne seguirono altre:
-
Hecho, nei Pirenei, il 19 marzo 1932,;
-
Bilbao nel 1932, con l'appoggio della
signorina María Pilar de Arratia, il cui nome e la cui vita rimarranno
per sempre legati alla Congregazione dell'Amore Misericordioso. Questo
collegio nel 1937 si trasferì all’attuale edificio.
-
Il 29 ottobre 1933 si aprì il collegio di
Larrondo (Biscaglia).
Nel 1933 s’ inaugura el collegio de
Santurce (Biscaglia).
Nel 1934 si apre il collegio de San
Sebastiano,
Nello stesso anno si apre pure il collegio
de Sestao.
Nel 1935 fonda un altro collegio a
Colloto, Asturias, in una regione di minatori, dove la propaganda
comunista e anticristiana era molto forte.
Ancora nel 1935 apre, una casa in
Ochandiano, Alava, da lei chiamata la "casa di tutti" perché dava
rifugio oltre che agli anziani in essa ricoverati, anche a tutti i
poveri che arrivavano; (fu distrutta durante la guerra spagnola).
Nel 1936 si trasferisce a Roma, dove
fonda il primo collegio in Italia, Villa Certosa
Nel 1938 , anche se ha la sua residenza a
Roma, la Madre Speranza apre i collegi di Villava, Pamplona e di
Menagaray, Alava.






Soltanto 4 di
questi collegi hanno in questi momenti un’altra finalità, gli altri
continuano ancora con la loro funzione originaria, e in ognuno di
essi s’imparte un’educazione
regolata
e di qualità ad una media di 380 bambini e bambine, tra i 0 e i 16
anni.

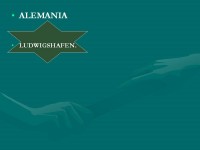
A queste fondazioni
spagnole seguirono quelle in Italia, Todi, Pavia, Genova, Fratta Todina,
Collevalenza, Francenigo, Borsea, Fermo, S. Vittoria in Materano, Vazzola, e
in Germania, Ludwigshafen...
L'ideale educativo di
Madre Speranza, era creare una scuola di qualità per i poveri, ma in quel
panorama sociale si vide costretta ad attendere in primo i bisogni più
urgenti dell'infanzia bisognosa: pulizia, alimentazione, alloggio, abiti di
condotta; tuttavia, l'educazione-istruzione dell’ infanzia e della gioventù
costituì -e costituisce ancora oggi -, la principale opera a cui dedicò la
sua Congregazione:
"Nel mese di
maggio del 1929 capì che doveva realizzarsi la fondazione di una
Congregazione, chiamata Ancelle dell’ Amore Misericordioso, che avrebbe
avuto lo scopo di aprire dei collegi ed educare in essi bambini orfani,
poveri e figli di famiglie numerose e delle classi umili della
società... eliminando da questi collegi tutto ciò che possa conferire
aspetto di asilo... Capì, anche, che in questi collegi i bambini
dovevano ricevere una solida educazione; inoltre, coloro che per la loro
intelligenza fossero capaci, potessero accedere agli studi superiori...
giacché questo, in genere,
non è possibile ai poveri, e molto
meno nella Spagna dove l'educazione del povero è tanto trascurata".
E stabilì nelle
Costituzioni della sua Congregazione che: "Tra le opere di carità in
primo luogo è l’educazione e l'istruzione dell'infanzia bisognosa.
Opera ardua da
realizzare in quel particolare momento storico, ma che avrebbe
caratterizzato il suo Istituto attraverso gli anni.
Ancora nel 1968, in
una delle ultime esortazioni a tutte le Suore della Congregazione, Madre
Speranza affermava:
"Siamo nate per i
poveri e il Signore non permetterà che ci manchi il necessario se noi siamo
fedeli alla nostra vocazione".
L’EDUCAZIONE PER
MADRE SPERANZA
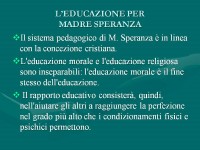 Se ci domandiamo se
M. Speranza è stata una pedagogista, dovremmo risponderci di no. Ella,
infatti, non ha formulato, intenzionalmente, una teoria pedagogica
sistematica; ma, data la sua mentalità pratica, capiva bene che quello che
mancava non erano le teorie, ma le azioni. E nella sua attività ha seguito
dei principi ben precisi che ha lasciato sparsi nelle pagine dei suoi
scritti. Fu perciò sempre una educatrice vivace, geniale ed efficiente.
Se ci domandiamo se
M. Speranza è stata una pedagogista, dovremmo risponderci di no. Ella,
infatti, non ha formulato, intenzionalmente, una teoria pedagogica
sistematica; ma, data la sua mentalità pratica, capiva bene che quello che
mancava non erano le teorie, ma le azioni. E nella sua attività ha seguito
dei principi ben precisi che ha lasciato sparsi nelle pagine dei suoi
scritti. Fu perciò sempre una educatrice vivace, geniale ed efficiente.
Il sistema pedagogico
di M. Speranza è perfettamente in linea con la concezione cristiana
dell'educazione, caratterizzata dalla tendenza all'unità e alla sintesi. La
pedagogia d’ispirazione cristiana, lungi dal menomare la natura umana, la
eleva, la vivifica, la benedice. Essa propone il concetto dell'uomo totale,
uno, con la sua personalità autonoma, con la sua anima immortale e con la
sua aspirazione verso Dio.
Tutti gli
insegnamenti, da quello fisico a quello morale acquistano nuova dignità in
funzione dell'uomo nella sua interezza.
L'educazione morale e
l'educazione religiosa sono inseparabili, giacché l'educazione del carattere
e della volontà, che costituiscono l'educazione morale, non possono essere
durature, complete ed umane se non sono dirette al centro più profondo
dell'uomo, cioè alla sua trasformazione morale-religiosa.
Questo non toglie
valore agli altri insegnamenti, anzi riconosce che i risultati
dell'educazione nei diversi piani: fisico, intellettuale, professionale,
sociale, civico, sessuale, estetico, dipenderanno in gran parte dal
carattere, dalla moralità e dalla religiosità dell'individuo.
E' fondata, quindi,
la preminenza che assume, non soltanto in Madre Speranza, ma in tutta la
pedagogia cattolica, l'educazione morale. Essa viene considerata non un
aspetto dell'educazione da mettere accanto ad altri, ma diventa il fine
stesso dell'educazione.
Dire "educazione
morale", perciò, è una espressione tautologica in quanto l'educare è sempre
un educare alla vita morale e d'altra parte un vivere morale è di per se
stesso un fatto educativo... L'esercizio della moralità ha un ambito segnato
a monte dall'esperienza religiosa e a valle dal comportamento. Quando si
assume, infatti, la prospettiva cristiana della vita, non solo si determina
una precisa scelta etico-religiosa, ma anche pedagogica; poiché il Vangelo
esige una dedizione integrale, così l'educazione deve corrispondere ad una
formazione altrettanto integrale.
Concezione e origine
dell’uomo
Il primo principio
che cerca di fondare Madre Speranza nei suoi scritti é quello dell'origine e
del fine dell'uomo.
L'origine dell'uomo è
Dio che, nella sua infinita bontà, ha creato innumerevoli esseri, superiori
ed inferiori all'uomo, e ad ognuno ha dato una missione particolare.
L'essere umano,
essendo stato creato diverso dagli animali e dagli angeli, è evidente che
porti nella sua stessa struttura la volontà di Dio, che diventa per lui la
sua vocazione. La vocazione primordiale dell'uomo, quindi, è quella di
"essere uomo".
Egli, perciò, non
potrà realizzare pienamente la sua vocazione divina se non realizza in primo
luogo la vocazione umana, cioè lo sviluppo di tutte quelle funzioni o
potenze che Dio ha messo nella sua natura.
La persona sulla
terra ha due fini: un fine primordiale, che é l'unione con Dio, ed un fine
particolare, che è il raggiungimento del fine primordiale in modo tutto
personale, attraverso lo sviluppo di tutte le sue capacità. A questo deve
essere indirizzata l'opera educativa. Cioè dobbiamo crescere.
Il ruolo delle
creature
Dio vuole che
cresciamo in questo mondo e che dilatiamo le capacità del nostro essere per
l'eternità; sono le creature che ci aiutano in questa crescita, noi infatti
ci serviamo di loro.
L'uso delle cose
contribuisce al nostro sviluppo fisico, razionale, intellettuale e morale;
tuttavia l'uomo può servirsi delle cose create non per la propria
costruzione, ma unicamente per la propria soddisfazione. Così il piacere da
mezzo diventa fine. Ecco il male. Anziché progredire nella perfezione l'uomo
si ferma. E' questa la prima tentazione della nostra natura e la più forte
inclinazione. Il male non è nel desiderio della soddisfazione, quanto nel
modo con cui la cerchiamo e nello squilibrio che operiamo in noi per
appagarla.
E così come non
dobbiamo trascurare il soprannaturale per il materiale, nemmeno dobbiamo
tralasciare la parte materiale per quella spirituale. Non siamo né puro
spirito né pura materia, ma l'unione dell'uno e dell'altra.
Questa idea acquista
nelle Lettere della Madre un tono profondamente umano e familiare,
così dice alle Superiore: "Ci sono delle Superiore che rivolgono tutta
l'attenzione alle cure temporali trascurando il profitto spirituale delle
anime. Ci sono altre che, ritenendosi molto spirituali, mettono tutto il
loro interesse nella cura spirituale, lasciando da parte la cura materiale,
abbandonando perfino le malate, e così s'inquietano per le coscienze di
tutte dimenticando la carità".
Quindi, il rapporto
educativo consisterà, secondo Madre Speranza, nell'aiutare gli altri a
raggiungere la perfezione nel grado più alto che i condizionamenti fisici e
psichici permettono, tenendo sempre di vista il fine.
La persona é perfetta
quando ha raggiunto tutte le possibilità di sviluppo. Ma esiste pure una
perfezione relativa in quanto la persona, nella vita, va acquistando diversi
gradi de perfezione; questi fini parziali sono come dei gradini per arrivare
alla perfezione assoluta. La persona si avvicina alla perfezione in modo
graduale e progressivo. Perciò nell’educazione, secondo la M. Speranza, ha
molta importanza la pazienza.
L’educazione é il
raggiungimento della virtù.
L'educazione come
raggiungimento della perfezione si fonda sulla conoscenza di Dio e di noi
stessi:
"La conoscenza di Dio
ci porta direttamente all'amore. La conoscenza di noi stessi ci farà stimare
nella giusta misura ciò che Dio ci ha dato e ci muoverà al ringraziamento e
ad un ulteriore sviluppo".
Anche se la natura
umana possiede questa capacità di perfezionarsi, tuttavia l'uomo rimane
totalmente libero di aderire o meno alla proposta divina.
Di fronte ai numerosi
ostacoli che impediscono o rallentano il progresso della propria formazione,
bisogna rinnovare sempre l'impegno ma senza sforzi disperati che farebbero
desistere, prima o poi, dall'impresa:
"Gli sforzi
violenti non sono mai durevoli, e i presuntuosi si scoraggiano davanti ai
primi fallimenti; per andare avanti é sufficiente un desiderio tranquillo,
sereno e riflessivo, fondato nella conoscenza e nella onnipotenza della
grazia di Dio".
Per la
Madre, la vita é una grande scuola di perfezione, e ci pone in guardia su
due pericoli che potremmo trovare nel nostro cammino: il primo é la
pigrizia, cioè, desiderare di essere perfetti ma rimandare ad un altro
giorno il mettere in pratica i mezzi per raggiungerla. Il secondo é il
disprezzo delle piccole cose; cioè rimanere in attesa delle grandi occasioni
e lasciar perdere quelle piccole che la vita ci offre giorno per giorno.
Ecco dunque che nella
concezione cristiana niente di umano viene perso; non è un trascurare il
temporale per l'eterno, ma è un formarsi per mezzo dei beni temporali ad una
pienezza di vita, la più alta possibile, per l'eternità. Così l'intelligenza
acquista un gran valore perché, essendo il primo principio degli atti umani,
essa ci dice ciò che dobbiamo fare e ciò che dobbiamo evitare in rapporto al
fine ultimo.
La Madre ci presenta
le virtù come delle potenzialità ordinate al bene, come quelle che
potenziano e umanizzano il nostro agire; sono l’aiuto di Dio per illuminare
il nostro intelletto e rafforzare la nostra volontà. Così pure le passioni,
che ben dominate e ben gestite, sono delle forze che ci spingono ad agire.
Il rapporto educativo
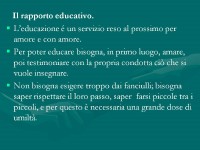 Madre Speranza
concepisce l’educazione come un servizio reso al prossimo per amore e con
amore. "Se vi circondate della luce del Signore, sarete voi stesse luce,
e in questa luce divina lavorerete con frutto nella vostra perfezione e in
quella dei bambini a voi affidati. e così come la luce ha due effetti
principali che sono: diffondere intorno il chiarore e il calore, così la
grazia di Dio produce altri due effetti simili: illuminare l'intelletto e
vivificare la volontà".
Madre Speranza
concepisce l’educazione come un servizio reso al prossimo per amore e con
amore. "Se vi circondate della luce del Signore, sarete voi stesse luce,
e in questa luce divina lavorerete con frutto nella vostra perfezione e in
quella dei bambini a voi affidati. e così come la luce ha due effetti
principali che sono: diffondere intorno il chiarore e il calore, così la
grazia di Dio produce altri due effetti simili: illuminare l'intelletto e
vivificare la volontà".
Diceva Andrés
Manjón: Siamo cattivi perché nessuno ci ha insegnato ad essere buoni.
Cioè il bene s’impara.
Madre Speranza viene
ad esprimere la stessa idea quando dice. Noi siamo responsabili di quello
che il povero faccia per ignoranza, per non conoscere Dio; così lo sviluppo
delle capacità intellettuali deve precedere lo sviluppo delle virtù, perché
è compito dell'intelletto presentare il bene alla volontà, affinché questa
lo riconosca e lo accetti come tale. Ma per poter educare bisogna, in
primo luogo, amare, poi testimoniare con la propria condotta
ciò che si vuole insegnare; aiutare gli educandi a conoscere se stessi, le
proprie debolezze e le difficoltà della vita, perché possano vincerle.
Tuttavia non bisogna
esigere troppo dai fanciulli; bisogna saper rispettare il loro passo, saper
farsi piccole tra i piccoli, e per questo è necessaria una grande dosi d’
umiltà:
"(L'educatrice)
deve presentarsi piccola e umile di fronte agli educandi, senza mai
pretendere di mantenere l'autorità con la forza. San Paolo diceva che si
faceva piccolo tra i piccoli, e io vi dico, figlie mie, siate come madri:
umili, prudenti e caritatevole e vi guadagnerete il rispetto, la fiducia,
l'obbedienza e l'amore dei figli".
Virtù che deve
possedere l’educatore
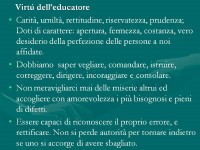 La Madre presenta
così la figura della educatrice:
La Madre presenta
così la figura della educatrice:
Per poter guidare e
dirigere gli altri, dobbiamo avere le virtù di una madre: carità, umiltà,
rettitudine, riservatezza, prudenza; dobbiamo possedere anche altre doti di
carattere, come: l’apertura, la fermezza, la costanza, un vero desiderio
della perfezione delle persone a noi affidate, e perciò dobbiamo saper
vegliare, comandare, istruire, correggere, dirigere, incoraggiare e
consolare. Non meravigliarci mai delle miserie altrui ed accogliere con
amorevolezza i più bisognosi e pieni di difetti. Essere capaci di
riconoscere il proprio errore, e rettificare; perché mai si perde autorità
per tornare indietro quando uno si accorge di avere sbagliato; tuttavia, non
bisogna cambiare facilmente le decisioni prese, perché questo potrebbe
significare mancanza di riflessione e potrebbe generare negli altri
insicurezza e diffidenza.
Regole d’oro per
essere ubbiditi dai bambini
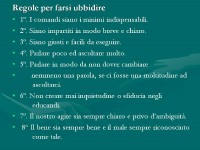 E’ necessario:
E’ necessario:
1º. Che i comandi
siano i minimi indispensabili.
2º. Che siano
impartiti in modo breve e chiaro.
3º. Che siano giusti
e facili da eseguire.
4º. Parlare poco ed
ascoltare molto.
5º. Quando parliamo
farlo in modo da non dover cambiare, nemmeno una parola,
se ci fosse una moltitudine ad ascoltarci.
6º. Non creare mai
inquietudine o sfiducia negli educandi.
7º. Il nostro agire
sia sempre chiaro e privo d’ambiguità.
8° Il bene sia sempre
bene e il male sempre riconosciuto come tale.
Per essere ubbidite
bisogna farsi amare, e chi non si prende cura di guadagnare i cuori e si
accontenta di vigilare, comandare, riprendere e castigare, mai sarà una
madre ma una dura signora.
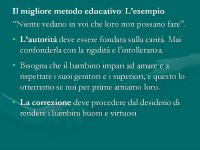 Lo spirito materno,
l’affabilità e l'indulgenza, che sono l’espressione della carità, pervadono
tutta l’opera educativa di M. Speranza; è essenziale sentire come propri i
figli che la Provvidenza ci affida per poter procurare loro il meglio.
Lo spirito materno,
l’affabilità e l'indulgenza, che sono l’espressione della carità, pervadono
tutta l’opera educativa di M. Speranza; è essenziale sentire come propri i
figli che la Provvidenza ci affida per poter procurare loro il meglio.
Tuttavia, Il migliore
e il principale dei metodi educativi per la Madre Speranza è l’esempio.
"Niente vedano in voi che loro non possano fare". "I consigli che non vanno
accompagnati dall’esempio nulla valgono".
Spirito di
collaborazione ed aiuto reciproco.
Per Madre
Speranza é molto importante il lavoro in perfetta collaborazione. "Il
saggio che pretende bastare a se stesso si impiccolisce fino al suo scarso
valore individuale e non vede se non a metà".
Quindi, non soltanto,
dobbiamo accogliere bene i consigli che ci vengono dati, ma perfino bisogna
cercarli con umiltà e desiderio di metterli in pratica, senza dimenticare
mai che la presunzione offusca l’intelligenza. "E il Signore lo permette,
dice la Madre, perché ricorriamo al parere di quelli che vedono ciò
che noi non vediamo ed ascoltiamo i loro consigli". la Madre, perciò,
consiglia a tutti noi di aprirci al dialogo fraterno e ad una sana
collaborazione per non disperdere le forze.
L’autorità e le
correzioni
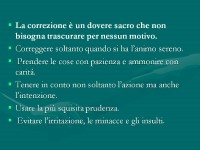 L’autorità deve
essere sempre fondata sulla carità e sulla mansuetudine. Inoltre non bisogna
mai confonderla con la rigidità e l’intolleranza. Il malumore, l’ira,
l’egoismo, l’orgoglio, l’amor proprio mai hanno degli effetti positivi.
L’autorità deve
essere sempre fondata sulla carità e sulla mansuetudine. Inoltre non bisogna
mai confonderla con la rigidità e l’intolleranza. Il malumore, l’ira,
l’egoismo, l’orgoglio, l’amor proprio mai hanno degli effetti positivi.
In primo luogo
bisogna far nascere nel bambino un grande rispetto per l'autorità di Dio,
perché l'autorità è un attributo che corrisponde a colui che è autore e
l’Autore per eccellenza è Dio.
Nello stesso tempo
bisogna che il bambino impari ad amare e a rispettare i suoi genitori e i
superiori, e questo lo otterremo se noi per prime amiamo loro.
Nell’educazione la
correzione é inevitabile.
La correzione deve
procedere dal desiderio di rendere i bambini buoni e virtuosi; perciò è
necessario reprimere l'ira, tanto interna quanto esterna e usare grande
benignità. Prima di giudicare l'operato di un educando bisogna considerare
bene non soltanto l'opera in sé, ma anche l'intenzione con cui è stata
compiuta: "Se l'opera è buona, è un errore prenderla per cattiva, se è
dubbiosa non bisogna attribuirla al vizio, e se veramente è cattiva, vedi
come puoi salvare l'intenzione e attribuirla alla fragilità, all’ignoranza e
alla debolezza".
Per fare una
correzione, la Madre considera una serie di elementi che deve tener
presenti colui che la fa: La correzione anzi tutto é un atto di misericordia
il cui fine é rendere migliore all’altro. Tenendo presente che le virtù che
devono presiedere la relazione educativa sono la carità, il rispetto,
l’affabilità e la condiscendenza , nel correggere bisognerà:
-
correggere soltanto quando si ha l’animo
sereno e lo spirito tranquillo e reprimere l’ira, tanto interna come
esterna. Perciò é consigliabile aspettare che il fuoco dell’impetuosità
sia passato e che la pace e la serenità si siano ristabilite nel nostro
animo;
-
prendere le cose con pazienza, pregare e
ammonire con carità;
-
tener in conto non soltanto l’azione ma
anche l’intenzione, e se questa é buona, attribuire l’azione alla
fragilità, all’ignoranza o alla debolezza.
-
usare la più squisita prudenza, perché
l’imprudenza fa perdere ad ogni azione il suo merito;
-
evitare l’irritazione, le minacciare e gli
insulti, le parole poco educate... E’ tanto facile gridare e
castigare, che per farlo non abbiamo bisogno di maestri, perché
lo portiamo nella nostra natura;
-
molte volte non é buono correggere nello
stesso momento in cui si vede lo sbaglio, perché si impedisce all’altro
di accorgersi da solo del proprio errore. (con i bambini piccoli la
correzione é meglio farla subito, perché possono dimenticare il motiv
della correzione).
La correzione è un
dovere sacro che non bisogna trascurare per nessun motivo: La vera
madre accetta tutto, veglia su tutto e cerca di rendere forte lo spirito dei
figli. E' cosciente che l'autorità non la trasforma in una nuova creatura e
perciò anche lei è capace di sbagliare... per questo non si meraviglia
dei difetti altrui, e con uno sguardo materno e costante segue i suoi figli
rendendosi conto ... perfino dei più piccoli atteggiamenti della loro
condotta. Il castigo e la correzione infondono saggezza, mentre il
bambino abbandonato al proprio capriccio è simile ad un cavallo indomito che
sprofonda nel precipizio. Ma una volta corretto il bambino di un difetto,
non bisogna ricordarglielo più, perché la correzione non è né un insulto, né
un oltraggio, ma un atto di carità.
Perciò, - conclude -
penso che per educare i bambini c’è più utile il cuore che la scienza, avere
più pazienza che metodo ed essere per loro più madri che maestre.
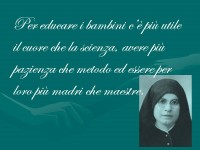
PANORAMICA POLITICA, SOCIALE E RELIGIOSA
"Per questo, si
avvicina una terribile rivoluzione, giacché i poveri, per la loro ignoranza
religiosa e intellettuale, sono un vero disastro e i nemici della fede sanno
bene che possono spingerli a grandi massacri con piccoli sforzi".