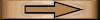COLLEVALENZA - 26 settembre 2021, festa del Santuario
C
ari fratelli e sorelle, vi do, anzitutto, un caldo benvenuto a questa festa del Santuario dell’Amore Misericordioso, con l’augurio che possiamo vivere insieme un momento di grazia e benedizione. Non dovrei essere io a rivolgervi la parola in questa festa importante, ma vi confesso che abbiamo provato a contattare vescovi e cardinali… senza successo. Tutti molto impegnati di questi tempi… quindi dovrete accontentarvi…Abbiamo creduto che fosse opportuno, in questo momento, respirare con la Chiesa universale, e metterci in sintonia con l’iniziativa così importante che Papa Francesco propone a tutta la Chiesa Cattolica, e non solo, e che prenderà l’avvio tra pochi giorni, nel mese di ottobre. Si tratta della convocazione a riscoprire in tutta la Chiesa l’importanza della sinodalità, cioè del camminare insieme, come cercheremo di vedere, e che abbraccerà un cammino in tutta la Chiesa di ben tre anni, dal 2021 al 2023. Al rispetto è stato inviato dal Vaticano un Documento preparatorio che ha per titolo:
Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione e missione
In tutte le Chiese e a tutti i livelli, quindi anche noi oggi qui, siamo invitati a prendere coscienza di questa realtà. Anche questo è un modo di ascoltare ciò che lo Spirito dice alla Chiesa e alle chiese (cf Apocalisse). Proviamo a vedere insieme il perché, seguendo in particolare il Documento preparatorio.
«Proprio il cammino della sinodalità è il cammino che Dio si aspetta dalla Chiesa del terzo millennio»1. Questa affermazione chiara e direi programmatica, è stata fatta da Papa Francesco il 17 ottobre del 2015, anno della misericordia, commemorando il 50° anniversario dell’istituzione del Sinodo dei Vescovi. Mi sembra molto significativo che proprio nell’anno della misericordia, istituito per la prima volta nella storia della Chiesa, ci sia stata questa sottolineatura della sinodalità, come metodo di cammino per la Chiesa.
Credo sia da approfondire questo legame tra la sinodalità e la misericordia.
Sinodo, parola che viene dal greco, significa letteralmente "cammino insieme".
"Quello che il Signore ci chiede, in un certo senso, è già tutto contenuto nella parola Sinodo. Camminare insieme – Laici, Pastori, Vescovo di Roma – è un concetto facile da esprimere a parole, ma non così facile da mettere in pratica"2.
Capite che non siamo di fronte a un’esigenza dettata da un prurito di novità o democraticismo di moda, si tratta di uno stile propriamente evangelico, forse un po’ dimenticato nel corso dei tempi, anche se mai assopito nella Chiesa: "… sinodalità come forma, come stile e come struttura della Chiesa"3.
Nasce una domanda di fondo: "come si realizza oggi, a diversi livelli (da quello locale a quello universale) quel ‘camminare insieme’ che permette alla Chiesa di annunciare il Vangelo, conformemente alla missione che le è stata affidata; e quali passi lo Spirito ci invita a compiere per crescere come Chiesa sinodale?"4
Per rispondere a questa domanda il DP fa anzitutto un’analisi del contesto in cui viviamo.
IL CONTESTO IN CUI VIVIAMO
Stiamo vivendo, è sotto gli occhi di tutti, un momento storico segnato da cambiamenti epocali della società e passaggi cruciali nella vita della Chiesa (cf DP 4).
Pensiamo alla pandemia da COVID-19, una tragedia e una sfida per tutta l’umanità, in particolare per le persone più vulnerabili e bisognose. Tale evento «ha effettivamente suscitato per un certo tempo la consapevolezza di essere una comunità mondiale che naviga sulla stessa barca, dove il male di uno va a danno di tutti: ci siamo ricordati che nessuno si salva da solo, che ci si può salvare unicamente insieme» (FT, n. 32)
Al tempo stesso la pandemia ha fatto esplodere le tremende e inique disuguaglianze già esistenti.
"A più di un anno e mezzo dall’inizio della crisi sanitaria possiamo pensare al futuro con maggiore ottimismo… Dopo mesi di solitudine, la nostra vita sociale è finalmente ricominciata. La pandemia non è però finita e anche quando lo sarà, avremo a lungo a che fare con le sue conseguenze. A livello globale, abbiamo davanti differenze drammatiche nella diffusione dei vaccini. Nei Paesi ad alto reddito, più del 65% della popolazione ha ricevuto almeno una dose. Nei Paesi più poveri, solo il 2%. Queste disparità sono moralmente inaccettabili: meno vaccinazioni equivalgono a più morti. Inoltre, finché il virus continuerà a circolare liberamente, potrà mutare in modo pericoloso e mettere a rischio anche le campagne di vaccinazione più efficaci. Occorre aumentare la disponibilità di vaccini per i Paesi poveri e risolvere i problemi logistici perché le dosi arrivino dove c’è maggiormente bisogno…"5
L’umanità appare sempre più scossa da processi di massificazione e di frammentazione; la tragica condizione che i migranti vivono in tutte le regioni del mondo testimonia quanto alte e robuste siano ancora le barriere che dividono l’unica famiglia umana. (cf DP 5). Pensiamo in questi giorni alla grande massa degli haitiani sulla frontiera degli USA.
Ma anche vicino a noi, quanta gente ha sofferto e sta soffrendo le conseguenze della pandemia: quanti lutti, perdite del lavoro, tragedie familiari, depressioni anche tra i giovani e persino i bambini, esperienze drammatiche di gente sola (è stato bello per noi qui del Santuario riscontrare il conforto grande che ha costituito per molte persone, soprattutto anziane e sole, la trasmissione delle S. Messe da Collevalenza durante la pandemia) … Davvero il Signore trova il modo di essere vicino, quando tutto sembra chiuso e bloccato.
Certamente tutto ciò costituisce una sfida per noi cristiani, perché le crisi hanno di buono che smascherano false sicurezze, invitano ad andare all’essenziale. La Chiesa si trova di fronte alla sfida di affrontare la mancanza di fede, di speranza e di amore, e la corruzione anche al suo interno. In particolare non possiamo dimenticare la sofferenza vissuta da minori e persone vulnerabili «a causa di abusi sessuali, di potere e di coscienza commessi da un numero notevole di chierici e persone consacrate»6.
Pensiamo, poi, alla varietà delle condizioni in cui vivono le comunità cristiane nelle diverse regioni del mondo. Accanto a Paesi in cui la Chiesa costituisce la maggioranza della popolazione e rappresenta un riferimento culturale per l’intera società, ce ne sono altri in cui i cattolici sono una minoranza; in alcuni di questi i cattolici, insieme agli altri cristiani, sperimentano forme di persecuzione anche molto violente, e non di rado il martirio.
Vediamo così che, soprattutto nella nostra società – così detta del benessere - domina una mentalità secolarizzata che tende a espellere la religione dallo spazio pubblico, mentre in altri paesi vediamo un integralismo religioso che non rispetta le libertà altrui, alimenta forme di intolleranza e di violenza che si riflettono anche nella comunità cristiana e nei suoi rapporti con la società. Non di rado i cristiani assumono i medesimi atteggiamenti, fomentando le divisioni e le contrapposizioni anche nella Chiesa… (chissà se a volte siamo un po’ talebani anche noi …) (cf DP 8).
All’interno di questo contesto, la sinodalità rappresenta la strada maestra per la Chiesa, chiamata a rinnovarsi sotto l’azione dello Spirito e grazie all’ascolto della Parola che si incarna negli eventi concreti della storia.
La capacità di immaginare e di realizzare un futuro diverso per la Chiesa e per le sue istituzioni, che sia all’altezza della missione ricevuta e di ciò che oggi il Signore ci chiede, dipende in larga parte dalla scelta di avviare processi di ascolto, dialogo e discernimento comunitario, a cui tutti e ciascuno possano partecipare e contribuire.
Al tempo stesso, la scelta di "camminare insieme" è un segno profetico per una famiglia umana che ha bisogno di un progetto condiviso, in grado di perseguire il bene di tutti … (cf DP 9)
UNA CHIESA COSTITUTIVAMENTE SINODALE
«Quello che il Signore ci chiede, in un certo senso, è già tutto contenuto nella parola "Sinodo"»7, che «è parola antica e veneranda nella Tradizione della Chiesa, il cui significato richiama i contenuti più profondi della Rivelazione»8. È il «Signore Gesù che presenta sé stesso come "la via, la verità e la vita" (Gv 14,6)», e «i cristiani, alla sua sequela, sono in origine chiamati "i discepoli della via" (cfr At 9,2; 19,9.23; 22,4; 24, 14.22)»9. Gesù stesso, il Figlio di Dio fatto uomo, ha voluto camminare con noi. Lui è infatti il "Dio con noi", che lascia questo mondo con queste parole ai suoi: "Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo".
La sinodalità in questa prospettiva è ben più che la celebrazione di incontri ecclesiali e assemblee di Vescovi, o una questione di semplice amministrazione interna alla Chiesa; essa «indica lo specifico modus vivendi et operandi della Chiesa Popolo di Dio che manifesta e realizza in concreto il suo essere comunione nel camminare insieme, nel radunarsi in assemblea e nel partecipare attivamente di tutti i suoi membri alla sua missione evangelizzatrice»10. Si intrecciano così quelli che il titolo del Sinodo propone come assi portanti di una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione e missione. (cf DP 10)
E questo, guardate, non è un’invenzione di Papa Francesco. Nel primo millennio, "camminare insieme", cioè praticare la sinodalità, è stato il modo di procedere abituale della Chiesa compresa come «Popolo radunato dall’unità del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo»11. A coloro che dividevano il corpo ecclesiale – ci sono stati sempre, non vi spaventate, e tutti contribuiamo! -, i Padri della Chiesa hanno opposto la comunione delle Chiese sparse per il mondo, che S. Agostino descriveva come l’accordo nella fede di tutti i Battezzati («concordissima fidei conspiratio»12).
Qui si fonda la prassi sinodale a tutti i livelli della vita della Chiesa – locale e universale, con i gradi intermedi –, che ha trovato nel concilio ecumenico la sua manifestazione più alta. È in questo orizzonte ecclesiale, ispirato al principio della partecipazione di tutti alla vita ecclesiale, che S. Giovanni Crisostomo poteva dire: «Chiesa e Sinodo sono sinonimi»13. (cf DP 11)
In questo solco fecondo della Tradizione si è inserito il Concilio Vaticano II. Esso mette in rilievo che «è piaciuto a Dio di santificare e salvare gli uomini non separatamente e senza alcun legame tra di loro, ma ha voluto costituirli in un popolo che lo riconoscesse nella verità e lo servisse nella santità» (LG, n. 9). I membri del Popolo di Dio sono accomunati dal Battesimo e «se anche per volontà di Cristo alcuni sono costituiti dottori, dispensatori dei misteri e pastori a vantaggio degli altri, fra tutti però vige vera uguaglianza quanto alla dignità e all’azione nell’edificare il corpo di Cristo, che è comune a tutti i Fedeli» (LG, n. 32). Perciò tutti i Battezzati, partecipi della funzione sacerdotale, profetica e regale di Cristo, «nell’esercizio della multiforme e ordinata ricchezza dei loro carismi, delle loro vocazioni, dei loro ministeri»14 sono soggetti attivi di evangelizzazione, sia singolarmente sia come totalità del Popolo di Dio. (cf DP 12)
Sicuramente tutto ciò richiede una mentalità di partecipazione, che suppone una vera conversione all’interno della Chiesa. A volte abbiamo avuto uno stile troppo "clericale", che metteva i Pastori della Chiesa in un luogo di privilegio, separato dal "gregge", che doveva solo ascoltare e obbedire, ma non si sentiva partecipe e responsabile… Uno stile di sinodalità non comporta l’assunzione all’interno della Chiesa dei dinamismi della democrazia imperniati sul principio di maggioranza, perché alla base della partecipazione a ogni processo sinodale vi è la passione condivisa per la comune missione di evangelizzazione e non la rappresentanza di interessi in conflitto… S. Benedetto sottolinea come «spesso il Signore rivela la decisione migliore»15 a chi non occupa posizioni di rilievo nella comunità (in quel caso il più giovane)… (cf DP 14).
Nella Chiesa di Cristo «ciascuno ha qualcosa da imparare. Popolo fedele, Collegio episcopale, Vescovo di Roma: l’uno in ascolto degli altri; e tutti in ascolto dello Spirito Santo, lo "Spirito della verità" (Gv 14,17), per conoscere ciò che Egli "dice alle Chiese" (Ap 2,7)»16. Il Vescovo di Roma, quale principio e fondamento di unità della Chiesa, richiede a tutti i Vescovi e a tutte le Chiese particolari, nelle quali e a partire dalle quali esiste l’una e unica Chiesa cattolica (cfr. LG, n. 23), di entrare con fiducia e coraggio nel cammino della sinodalità. In questo "camminare insieme", chiediamo allo Spirito di farci scoprire come la comunione, che compone nell’unità la varietà dei doni, dei carismi, dei ministeri, sia per la missione: una Chiesa sinodale è una Chiesa "in uscita", una Chiesa missionaria, «con le porte aperte» (EG, n. 46).
Ciò include la chiamata ad approfondire le relazioni con le altre Chiese e comunità cristiane, con cui siamo uniti dall’unico Battesimo. La prospettiva del "camminare insieme", poi, è ancora più ampia, e abbraccia l’intera umanità, di cui condividiamo «le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce» (GS, n. 1).
Una Chiesa sinodale è un segno profetico soprattutto per una comunità delle nazioni incapace di proporre un progetto condiviso, attraverso il quale perseguire il bene di tutti: praticare la sinodalità è oggi per la Chiesa il modo più evidente per essere «sacramento universale di salvezza» (LG, n. 48), «segno e strumento dell’intima unione con Dio e dell’unità di tutto il genere umano» (LG, n. 1). (cf DP 15).
IN ASCOLTO DELLE SCRITTURE
Ma dove si fonda, possiamo chiederci, questo stile sinodale, di comunione e partecipazione all’interno della Chiesa? Può esserci solo un fondamento: La Parola di Dio, l’esempio si Gesù stesso, il modo in cui lo Spirito santo di Dio conduce la Chiesa lungo la storia.
Lo Spirito, secondo la promessa di Gesù, porta verso "la pienezza della verità" e ispira le decisioni necessarie a sostenere il cammino della Chiesa (cfr. Gv 14,25-26; 15,26-27; 16,12-15). Ci sono due "immagini" della Scrittura che possono ispirare il nostro cammino di costruzione di una Chiesa sinodale. 1. Una è costituita dalla "scena comunitaria" che accompagna costantemente il cammino dell’evangelizzazione. 2. L’altra fa riferimento all’esperienza dello Spirito in cui Pietro e la comunità primitiva superano il rischio di porre limiti all’universalità della salvezza. (cf DP 16).
Gesù, la folla, gli apostoli
Lungo tutto il Vangelo, Gesù annuncia la venuta del Regno di Dio con uno stile e con delle modalità particolari. Gli attori in gioco sono essenzialmente tre (più uno). Il primo naturalmente è Gesù, il protagonista assoluto che prende l’iniziativa, seminando le parole e i segni della venuta del Regno senza fare «preferenza di persone» (cfr. At 10,34). In varie forme, Gesù rivolge una speciale attenzione agli ultimi, agli esclusi, ai cosiddetti "separati" da Dio e "allontanati" dalla comunità (cf i lebbrosi, i samaritani…). "Non sono i sani che hanno bisogno del medico ma i malati. Non sono venuto a chiamare i giusti ma i peccatori" (cf DP 17).
Ora, nell’azione evangelizzatrice di Gesù, appare subito un secondo attore, che nei Vangeli viene indicato come la folla, la moltitudine del popolo, ossia l’insieme delle persone che lo seguono lungo il cammino, e a volte addirittura lo inseguono nella speranza di un segno e di una parola di salvezza.
L’annuncio evangelico non è rivolto solo a pochi illuminati o prescelti. L’interlocutore di Gesù è "il popolo" semplice, spesso smarrito "come pecore senza pastore", verso le quali lui prova una commozione viscerale, e alle quali annuncia la buona notizia del Regno di Dio, e compie segni di liberazione, guarigione, vita nuova. E questo lo fa in un modo che sorprende e talora scandalizza i presenti, soprattutto i capi del popolo: Gesù entra in dialogo con la Samaritana (cfr. Gv 4,1-42), donna socialmente e religiosamente compromessa; accoglie le lacrime e il profumo della donna peccatrice (cfr. Lc 7); guarisce il figlio del centurione e la figlia della donna cananea e di questi due pagani sottolinea con ammirazione la fede (cfr. Mt 8, 5-13; 15, 21-28) (cf DP 18)
Ma c’è anche un terzo attore. Tra coloro che seguono Gesù emergono gli apostoli che Lui stesso chiama, sin dall’inizio, li forma e li invia ad essere mediatori e strumenti della salvezza per tutti, in particolare per le folle stanche e senza pastore. L’elezione degli apostoli non è il privilegio di una posizione esclusiva di potere e di separazione, bensì la grazia di un ministero inclusivo di benedizione e di comunione. Grazie al dono dello Spirito del Signore risorto, costoro devono custodire il posto di Gesù, senza sostituirlo: solo Gesù è "la via, la verità, la vita", solo Lui è la luce del mondo, e gli apostoli, tutti i pastori e le mediazioni della grazia del Signore nel mondo sono un po’ come Giovanni il Battista: "non era lui la luce, ma veniva a rendere testimonianza alla luce". In questo senso tutti i pastori non devono mettere filtri alla sua presenza, o sostituirla, ma facilitarne l’incontro (cf DP 19).
"Gesù, la folla nella sua varietà, gli apostoli: ecco l’immagine e il mistero da contemplare e approfondire continuamente perché la Chiesa sempre più diventi ciò che è. Nessuno dei tre attori può uscire di scena. Se viene a mancare Gesù e al suo posto si insedia qualcun altro, la Chiesa diventa un contratto fra gli apostoli e la folla, il cui dialogo finirà per seguire la trama del gioco politico. Senza gli apostoli, autorizzati da Gesù e istruiti dallo Spirito, il rapporto con la verità evangelica si interrompe e la folla rimane esposta a un mito o una ideologia su Gesù, sia che lo accolga sia che lo rifiuti. Senza la folla, la relazione degli apostoli con Gesù si corrompe in una forma settaria e autoreferenziale della religione, e l’evangelizzazione perde la sua luce, che promana dalla rivelazione di sé che Dio rivolge a chiunque, direttamente, offrendogli la sua salvezza" (DP 20).
C’è poi l’attore "in più", l’antagonista, il "divisore" (diabolos significa "colui che divide") che tenta continuamente di mettere in atto la separazione diabolica dei primi tre. La prospettiva della croce scandalizza, ci sono discepoli che se ne vanno e folle che cambiano umore. C’è un apparente buon senso ("questo non ti accadrà mai!" dice Pietro a Gesù che parla della sua Passione), una sapienza mondana ("questo discorso è duro!"), una seduzione che promette mari e monti ("ti darò tutto questo se mi adori!"), con cui il divisore ci tenta…. Per sottrarsi agli inganni del "quarto attore" è necessaria una conversione continua. Emblematico a proposito è l’episodio del centurione Cornelio (cfr. At 10), antecedente di quel "concilio" di Gerusalemme (cfr. At 15) che costituisce un riferimento luminoso di una Chiesa sinodale (cf DP 21).
Una duplice conversione: Pietro e Cornelio (At 10)
L’episodio di At 10 narra la conversione di Cornelio, un centurione pagano dell’esercito di occupazione romano. Anche se pagano è un uomo retto, dedito alla preghiera e all’elemosina, cioè coltiva la relazione con Dio e si prende cura del prossimo. Proprio da lui entra sorprendentemente l’angelo, lo chiama per nome e lo esorta a mandare i suoi servi a Giaffa per chiamare Pietro.
La narrazione, a questo punto parla di un’altra conversione, quella di Pietro stesso, che quello stesso giorno ha ricevuto una visione, in cui una voce gli ordina di uccidere e mangiare degli animali, alcuni dei quali impuri. La sua risposta è decisa: «Non sia mai, Signore» (At 10,14. È la stessa cosa che aveva detto a Gesù che annunciava la sua Passione!) (cf DP 22).
L’apostolo rimane profondamente turbato e, mentre si interroga sul senso di quanto avvenuto, arrivano gli uomini mandati da Cornelio, che lo Spirito gli indica come suoi inviati. È una vera e propria conversione, un passaggio doloroso e immensamente fecondo di uscita dalle proprie categorie culturali e religiose:
Pietro accetta di mangiare insieme a dei pagani il cibo che aveva sempre considerato proibito. È nell’incontro con le persone, accogliendole, camminando insieme a loro ed entrando nelle loro case, che si rende conto del significato della sua visione: nessun essere umano è indegno agli occhi di Dio e la differenza istituita dall’elezione non è preferenza esclusiva, ma servizio e testimonianza di respiro universale (cf DP 23).
Sia Cornelio sia Pietro coinvolgono nel loro percorso di conversione altre persone, facendone compagni di cammino. L’azione apostolica realizza la volontà di Dio creando comunità, abbattendo steccati e promovendo l’incontro.
E quando, subito dopo, a Gerusalemme i fedeli circoncisi rimprovereranno Pietro, accusandolo di aver infranto le norme tradizionali, noncuranti della novità dell’effusione dello Spirito sui pagani: «Sei entrato in casa di uomini non circoncisi e hai mangiato insieme con loro!» (At 11,3), Pietro racconta quanto gli è accaduto e come il Signore gli ha aperto il cuore alla novità dello Spirito. Proprio questo aiuterà i suoi interlocutori, inizialmente aggressivi e refrattari, ad accogliere quello che è avvenuto. La Scrittura contribuirà a interpretarne il senso, come poi avverrà anche al "concilio" di Gerusalemme, in un processo di discernimento che è un ascolto dello Spirito in comune (cf DP 24).
MADRE SPERANZA e L’UNIVERSALITÀ DEL CARISMA DI MISERICORDIA
Permettete che faccia un riferimento finale alla novità che il carisma di Madre Speranza mi sembra abbia introdotto nella Chiesa, aiutando il superamento di certe "divisioni" un po’ tradizionali nella stessa vita consacrata, e facendo camminare insieme realtà fino a quel momento separate.
Spinta dal fuoco dell’Amore misericordioso del Signore, e cosciente che deve farlo conosce a tutti, come Gesù le ha indicato (cf Diario 5 novembre del 1927), il Signore le chiede di dar vita, anche in modo istituzionale, a delle realtà concrete che portino avanti l’ispirazione e il carisma che il Signore stesso le ha donato:
-
Fonda una famiglia religiosa che comprende le polarità, spesso in conflitto, del maschile e del femminile: due congregazioni ma un un’unica famiglia.
-
Lei, donna, fonda una Congregazione di uomini… non senza difficoltà. (cf "non c’è più giudeo né greco, uomo né donna, ma tutti voi siete uno in Cristo Gesù…").
-
A fronte della divisione tradizionale tra clero diocesano e clero religioso, Madre Speranza riceve l’ispirazione di affidare come missione peculiare ai Figli dell’Amore misericordioso l’unione dei religiosi con il clero diocesano, ma estende lo spirito di questa missione anche alle figlie e a "tutti coloro che vivono con me" (cf Diario, 18 dicembre 1927).
-
Di fronte alla divisione, anch’essa accentuata nella Chiesa, tra gerarchia e popolo di Dio, pastori e laici, Madre Speranza, anche qui sicuramente ispirata dal Signore, vuole sia tra le sue religiose che tra i suoi religiosi, delle sorelle e dei fratelli che svolgono la loro missione nelle strutture della vita civile, senza differenziarsi esternamente dalle altre persone.
-
Sulle orme della Madre, e seguendo le ispirazioni di cui sopra, la nostra Famiglia religiosa apre la ricchezza di questo carisma ai Laici, promuovendo, con l’approvazione della Chiesa, l’Associazione dei laici dell’Amore misericordioso, che nella vita quotidiana di tutti i giorni e negli ambiti più diversi, portano con la vita il lievito del vangelo di misericordia nel mondo.
Come vedete, siamo davanti a una realtà molto articolata, che abbraccia tutti, uomini donne, religiosi e laici, senza limiti di condizione sociale, o posizione gerarchica… tutti chiamati a camminare insieme, esprimendo ognuno, secondo la sua peculiare esperienza e doni, la ricchezza della misericordia del Signore, e la missione di farlo conoscere a tutti…
Madre Speranza aveva attinto questo fuoco e questa missione di farlo conoscere "in tutto il mondo", al cuore stesso di Gesù. E solo a questo cuore possiamo attingerlo anche noi. Tra le sue preghiere ne cito due, con le quali concludo, prese dalla novena all’Amore misericordioso:
"Gesù mio, so che tu rialzi i caduti, liberi dal carcere i prigionieri, non respingi nessun afflitto e guardi con amore e misericordia tutti i bisognosi…" (3° giorno)
"Gesù mio, so che tu chiami tutti senza eccezione, abiti negli umili, ami chi ti ama, giudichi la causa del povero, hai pietà di tutti e nulla disprezzi di quanto il tuo potere ha creato, dissimuli le mancanze degli uomini, li attendi a penitenza e ricevi il peccatore con amore e misericordia…" (7° giorno).
Cari fratelli e sorelle, chiediamo al Signore la grazia, in questa festa del Santuario del suo Amore Misericordioso di camminare insieme, di aiutarci reciprocamente ad essere strumenti di questa misericordia di Dio che vuole arrivare a tutti, e "con tutti i mezzi, per confortare, aiutare e far felici i suoi figli". La Vergine Maria, con la sua mediazione materna, e Madre Speranza ci aiutino in questa bella e impegnativa missione.
1 FRANCESCO, Discorso per la Commemorazione del 50° anniversario dell’istituzione del Sinodo dei Vescovi (17 ottobre 2015).
2 Ivi
3 DP (Documento preparatorio) 2.
4 Ivi
5 DRAGHI, Discorso all’ONU, 23.09.2021.
6 FRANCESCO, Lettera al Popolo di Dio (20 agosto 2018), proemio.
7 FRANCESCO, Discorso per la Commemorazione del 50° anniversario dell’istituzione del Sinodo dei Vescovi.
8 CTI, La sinodalità nella vita e nella missione della Chiesa (2 marzo 2018), n. 3.
9 Ivi.
10 Ivi, n. 6.
11 CIPRIANO, De Oratione Dominica, 23: PL 4, 553.
12 AGOSTINO, Epistola 194, 31: PL 33, 885.
13 GIOVANNI CRISOSTOMO, Explicatio in Psalmum 149: PG 55, 493.
14 CTI, La sinodalità nella vita e nella missione della Chiesa, n. 6.
15 Regula S. Benedicti, III, 3.
16 FRANCESCO, Discorso per la Commemorazione del 50° anniversario dell’istituzione del Sinodo dei Vescovi.
| Foto di gruppo |
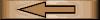 |
|
[Home page | Sommario Rivista]
realizzazione
webmaster@collevalenza.it
ultimo aggiornamento
18 ottobre, 2021