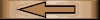 |
|
| S t u d i |
P. Aurelio Pérez fam |
...Con Tanta Delicatezza e Premura...
"E tu, Madre mia, che con tanta delicatezza e premura ti sei presa cura del buon Gesù, educami e aiutami nel compimento del mio dovere... Dì per me a Gesù: ricevi questo figlio, te lo raccomando con tutta l’insistenza del mio cuore materno"
I
n questo mese di maggio mi colpisce questa preghiera che Madre Speranza ci ha lasciato nel primo giorno della Novena all’Amore Misericordioso di Gesù. Mi sembra molto bello e utile alla vita secondo lo spirito contemplare, nella Vergine Santa, i tratti di delicatezza e premura, fondamentali in ogni opera di crescita umana e cristiana, con i quali Maria si è presa cura di Gesù e sicuramente si prende cura di ciascuno di noi.Credo utile soffermarci su alcuni dettagli di questi tratti, così fondamentali per acquistare uno stile veramente misericordioso.
La Delicatezza
Dice tante cose: finezza, tenerezza, cortesia, educazione, garbo, gentilezza, grazia, discrezione, riservatezza... sensibilità. In quanto tale è l’opposto di asprezza, grossolanità, maleducazione, sgarbo, rozzezza, scortesia, mancanza di sensibilità... Ognuna di queste sfumature potrebbe essere oggetto di riflessione e anche di verifica, per un sereno e sincero autoesame della nostra vita, provando a vedere quali di esse hanno la meglio nei nostri rapporti quotidiani, in particolare nelle relazioni di cura e responsabilità verso altri, soprattutto i più deboli.
La delicatezza, parente stretta della mitezza, è un tratto squisitamente materno e profondamente umano, e manifesta, anzitutto l’atteggiamento dovuto ad ogni persona in cui scorgiamo una realtà sacra, l’immagine stessa di Dio, il fratello e la sorella che, anche con le sue fragilità – e chi non ce le ha? – il Signore ci ha messo accanto.
Delicatezza dice anche "un atteggiamento di ascolto, di rispetto, di profonda stima di fronte a ciò che c’è in ogni uomo, per ciò che egli stesso, nell’intimo del suo spirito, ha elaborato riguardo ai problemi personali e più importanti" (S. Giovanni Paolo II, Redemtor hominis, 12).
Tenete presente che la durezza finisce per rovinare tutto: rende aspri i cuori, allontana la carità, genera odio, fa il bene di cattivo umore al punto che nessuno lo può gradire.
Quindi, lungi dall’essere un tratto formale di "buona educazione", che salva più o meno le apparenze, indica una dimensione di "rispetto" di fronte all’altro. S. Paolo, nell’Inno alla carità (1Cor 13), dice che "l’amore non manca di rispetto". Credo che la parola rispetto abbia delle connotazioni antropologiche di grande spessore. E al riguardo emerge anche una fatica, a volte una vera e propria lotta, di cui penso tutti facciamo esperienza.
C’è un aspetto di questa galassia di sfumature che compongono la delicatezza, che potrebbe creare confusione. Ci può essere una "falsa delicatezza"? Come essere delicati, per esempio, di fronte al male? È forse sinonimo di debolezza, di lasciar fare? Delicatezza non dice arrendevolezza e indifferenza di fronte al male, che va sempre chiamato per nome e affrontato nella verità. Dice piuttosto un modo attento, intelligente e pedagogicamente efficace di fronte a ogni situazione, anche la peggiore. Dice gradualità e saggezza nell’accompagnare, nel curare e anche nel correggere. La mano del chirurgo dev’essere delicata e, contemporaneamente, precisa e sicura nel maneggiare il bisturi, che di fronte a certi mali è necessario. Applicare pezze calde su un tumore è falsa delicatezza, estremamente nociva per chi ha un male che va tolto e curato.
In proposito mi sembrano una vera miniera di saggezza gli orientamenti che Madre Speranza dà ai responsabili delle comunità dell’Amore misericordioso, che penso possono essere fatti propri da chiunque si prende cura di qualcuno, genitore, evangelizzatore, educatore, catechista, insegnante... Lei sottolinea sempre la compresenza di due atteggiamenti che sembrano opposti, ma sono di fatto complementari:
Il nostro spirito umano è fatto in tal modo che si ribella contro il rigore però cede alla bontà... Tenete presente che la durezza finisce per rovinare tutto: rende aspri i cuori, allontana la carità, genera odio, fa il bene di cattivo umore al punto che nessuno lo può gradire; invece la mitezza fa quello che vuole del cuore...
Non siate eccessivamente accondiscendenti e tanto meno negligenti nei vostri doveri; non abbandonate mai la nave in balia delle onde; a somiglianza di cani muti che mai abbaiano contro i vizi, non lasciate correre l’acqua, cioè, non lasciate che si introducano abusi.
(Perché imparino ad essere padri e madri, nn. 57; 43)
È terreno per un buon discernimento, per niente facile, chiedendo allo Spirito di verità la luce per distinguere tra la zizzania che va tollerata nella crescita insieme al grano, e "l’occhio o la mano che sono occasioni di scandalo" e che vanno "tagliati", o le "potature del Padre" che permettono al tralcio di portare frutto.
In proposito mi ha colpito molto l’esperienza personale di Madre Speranza, trascritta nel Diario, dove appare la sua umiltà nel riconoscere la fatica del suo stesso carattere a coniugare la bontà delicata e rispettosa con la fermezza necessaria in certe circostanze. La ricerca di questo salutare equilibrio appare in vari dei suoi scritti, ma la trovo particolarmente eloquente nella crisi di P. Alfredo di Penta, primo Figlio dell’Amore Misericordioso, che aveva manifestato il rifiuto di andare a studiare al Seminario della Quercia di Viterbo. Nel Diario troviamo una preghiera a Gesù e un umile autoritratto del suo stesso carattere, diretto al Padre spirituale:
Solo Tu, Gesù, sai quanto soffro sentendo dire al padre che non è disposto ad andare in seminario, che piuttosto chiederà al vescovo la dispensa dei suoi voti! Gesù mio, aiutalo e fa che il mio temperamento si adatti con mitezza al carattere degli altri; infondi nel mio temperamento dolcezza, fortezza e tatto, di cui ho tanto bisogno, in questi difficili momenti, per compiere fedelmente la tua divina volontà e comportarmi da vera madre con questo religioso avvilito...
...guardare gli altri, non come avversari, come competitori o addirittura nemici, ma come esseri umani uguali a me in dignità, seppure diversi.
Speriamo, Padre mio, che il mio mal carattere non sia la causa di uno sconvolgimento del padre, e dico mal carattere, perché non si adatta facilmente al carattere altrui e mi manca quell’insieme di dolcezza e di fortezza, di franchezza e di tatto che dovrei possedere. Per questo anziché essere per me un potente aiuto per fare la volontà del Buon Gesù, comportandomi da madre con l’afflitto padre, spesso mi diventa un ostacolo per mancanza di carità, prudenza, fortezza e per notevole egoismo.
(El Pan 18, Diario di Madre Speranza, 3 marzo 1952, nn. 1162.1165)
Mi sembra che il "rispetto" sia l’arbitro che riesce a far giocare insieme questi due opposti, e farne un benefico strumento nelle relazioni tra le persone e nell’esercizio di responsabilità verso altri. Non basta averlo chiaro in teoria, ovviamente, almeno a me riesce molto difficile nella pratica, perché, nel perseguire questo difficile equilibrio, mi ritrovo con un carattere abbastanza peggiore di quello della Madre.
La parola rispetto ha a che fare con lo sguardo: rispetto viene dal latino "respicere", guardare. È un certo modo di guardare gli altri, non come avversari, come competitori o addirittura nemici, ma come esseri umani uguali a me in dignità, seppure diversi. La persona mite e rispettosa non è quella che lascia correre tutto, ma quella che guarda l’altro così come è, non come io lo vorrei, con un carattere, una sensibilità e una storia diversa dalla mia, e accetta il difficile compito di farsi compagno di strada, e persino di portare insieme qualche peso della vita. È una grazia da chiedere, come fa Madre Speranza: "Gesù mio, aiutalo e fa che il mio temperamento si adatti con mitezza al carattere degli altri". È anche un equilibrio da perseguire costantemente, aspirando a formarci un carattere in cui "regni la bontà, la fermezza, la dolcezza, la fortezza, la franchezza e il tatto" (Balance, p. 150).
La mitezza è una virtù che bandisce dai nostri cuori la collera, l’impazienza e il malumore; grazie alla mitezza siamo capaci di giudicare le cose senza passione, di amare senza osten tazione e di agire con semplicità, rettitudine e carità.
… sono molto necessarie fermezza e dolcezza, dato che una non è sufficiente senza l’altra, difatti la dolcezza senza la fermezza cessa di essere virtù e frequentemente degenera in debolezza; per questo è necessario unire la fermezza con la mitezza e fonderle a tal punto che dalle due risulti un temperamento indovinato.
(Perché imparino ad essere padri e madri, n. 62)
Certamente se l’umanità di Gesù ci è proposta come modello anche di un carattere maturo, quando Lui afferma "imparate da me che sono mite e umile di cuore", è legittimo pensare che nella sua formazione umana, fin dalla più tenera età abbiano influito, in modo decisivo, il carattere di Maria e anche quello di Giuseppe. Di qui l’importanza di riprodurre anche in noi questi tratti che, a detta di Madre Speranza, sono decisivi per "far del bene agli altri e a sé stessi":
La mitezza è una virtù che bandisce dai nostri cuori la collera, l’impazienza e il malumore; grazie alla mitezza siamo capaci di giudicare le cose senza passione, di amare senza ostentazione e di agire con semplicità, rettitudine e carità.
(Perché imparino ad essere padri e madri, n. 53)
Teniamo presente che la fermezza d’animo non è in contrasto con la bontà, con la carità né con la mitezza, anzi, al contrario, la fermezza è il complemento necessario di queste belle virtù, perché le conserva e le difende dalla debolezza, dalla incostanza, dalla eccessiva benignità e dalla debole accondiscendenza che le porterebbero alla rovina.
(Ib n. 60)
Il nostro carattere è un elemento molto efficace per avanzare nel cammino della santità e possiede una grande importanza per condurre le anime a Dio. Un buon carattere, infatti, che sappia adattarsi a quello degli altri è un validissimo aiuto per far camminare le anime verso la perfezione; così come un cattivo carattere è uno degli ostacoli più grandi per riuscire a fare del bene agli altri e a sé stessi.
(Libro delle Usanze FAM, parte I, cap 7°, §2)
La cura premurosa
È l’altra caratteristica che abbiamo visto in Maria nei confronti di Gesù e verso di noi. Dice attenzione mirata, prendersi a cuore le persone e le situazioni, nella loro unicità. È pertanto preoccupazione, sollecitudine, il contrario di negligenza, trascuratezza, disattenzione. La cura premurosa suppone l’affetto e l’interesse sincero per le persone, così come la noncuranza (= non prendersi cura), indica disaffezione e disinteressamento. È una sana inquietudine che sa vegliare, inventare, pazientare, curare i dettagli e non mollare di fronte alle difficoltà. È, in fondo, la caratteristica dell’amore di Dio verso di noi, che Madre Speranza definisce "instancabile".
Lo sguardo compassionevole è quello del samaritano di fronte al ferito, ben diverso dal vedere dei primi due che girano al largo. Il prendersi cura parte sempre da questo sguardo che fa la differenza”
Anche la premura, che è alla base dell’autentica cura, ha una galassia di sfumature che andrebbero tenute presenti nelle relazioni e in ogni opera educativa e di accompagnamento della fragilità. Lo sguardo di cui abbiamo parlato, che manifesta la delicatezza e il rispetto per la persona così come è, se lo applichiamo alla cura, acquista, secondo il vangelo, una connotazione particolare che esprimiamo con la parola "compassione". Lo sguardo compassionevole è quello del samaritano di fronte al ferito, ben diverso dal vedere dei primi due che girano al largo. Il prendersi cura parte sempre da questo sguardo che fa la differenza. È lo sguardo di Maria a Cana che coglie la necessità e il disagio, e li presenta a Gesù. È lo sguardo stesso di Gesù, pieno di compassione di fronte alle sofferenze che incontra, che provocano in lui una commozione viscerale e un intervento concreto per ammaestrare, guarire, dare vita, nutrire...
Anche a proposito della premura nel prendersi cura può sorgere una domanda: ci può essere una falsa premura? Certamente, in particolare quando la premura si confonde con l’ansia frettolosa che non sa cogliere la vera situazione dell’altro, il suo grado di maturità, ciò che è opportuno in quel momento. L’apprensione eccessiva è in fondo frutto di una scarsa conoscenza della persona che abbiamo davanti, del suo ritmo e dei suoi tempi di maturazione o, peggio ancora, di un voler paragonare gli altri con sé stessi, che, a detta di Madre Speranza, è uno dei peggiori errori nell’accompagnamento degli altri. Ritroviamo di nuovo il rispetto, che sa dare all’altro non ciò che a me piacerebbe, ma ciò di cui lui ha veramente bisogno, e contemporaneamente chiede solo ciò che l’altro può dare. Ancora una volta M. Speranza è illuminante:
Non dimenticate: non è buon Superiore quello che ottiene quello che lui desidera dai suoi figli, ma quello che riesce ad ottenere da loro quello di cui essi sono capaci.
(Perché imparino ad essere padri e madri, n. 116).
La vera premura tiene sempre in conto la gradualità. Il principio di gradualità, alla base di ogni autentica opera pedagogica, è molto sottolineato negli scritti di Madre Speranza e in tutta la testimonianza della sua vita. Lei diceva che Gesù, pur essendo esigente nel suo amore ("Non sarai tutto per me come io sono tutto per te?"), è molto delicato nei nostri confronti, e sa prendersi a cuore la gradualità della nostra maturazione spirituale.
Il “custodire” fa parte essenziale della cura dell’altro. Non a caso lo usiamo per indicare le azioni piene di attenzione e tenerezza di una madre (vedi Maria) verso il figlio piccolo, o quelle rivolte all’anziano, al malato, al debole o indifeso...?
26 Febbraio 1928: Questa notte il Buon Gesù mi ha ripetuto nuovamente che devo sforzarmi di più per distaccarmi totalmente dalle creature e unirmi completamente a Lui. Io, Padre, non riesco a capire dov’è questo attaccamento per tagliarlo di netto. La prego, mi aiuti lei.
Mi ha anche detto che desidera raddoppi l’impegno per progredire nella santità; però facendo attenzione perché tale desiderio non sia precipitoso né febbrile e, meno ancora, presuntuoso. Egli infatti dice che gli sforzi violenti non sono duraturi e i presuntuosi sempre si scoraggiano ai primi insuccessi. Mi avverte anche che, nel corso della mia vita e nel lavoro che sono chiamata a svolgere, mi troverò con l’impressione (e talvolta con la realtà) di grandi insuccessi. Cosa vorrà dire, Padre mio?
(El Pan 18, Diario, nn. 21-22)
Non mi soffermo - richiederebbe una considerazione a parte - sugli aspetti pratici del prendersi cura che abbracciano tutta una serie di atteggiamenti e azioni concrete, caratterizzate da sensibilità, dettagli, fedeltà, attenzione, previsione, impegno costante... Il buon samaritano, dopo aver visto il ferito ed essersi mosso a compassione, si avvicina, cura le ferite e poi accompagna all’albergo, si prende cura anche dell’evoluzione futura del ferito...
Il "custodire" fa parte essenziale della cura dell’altro. Non a caso lo usiamo per indicare le azioni piene di attenzione e tenerezza di una madre (vedi Maria) verso il figlio piccolo, o quelle rivolte all’anziano, al malato, al debole o indifeso... Chi non è in grado di prendersi cura di sé ha bisogno di qualcuno che lo custodisca. Custodire è anche l’azione di un padre (vedi S. Giuseppe il Custode) che difende, protegge dai pericoli, sa affrontare gli imprevisti e i rischi, provvede alle necessità quotidiane...
Maria e Giuseppe sono un riflesso fedele di quell’Amore eterno che ci ha creati e si prende cura di tutte le sue creature. Quell’Amore che ha dato la vita per noi, vive in noi per lo Spirito Santo, e ci dice: "Non vi lascerò orfani!" (Gv 14,18); "Io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo" (Mt 28,20).
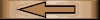 |
|
[Home page | Sommario Rivista]
realizzazione webmaster@collevalenza.it
ultimo aggiornamento
11 giugno, 2021